Si può riemergere dagli abissi della psiche fuggendo il pregiudizio?
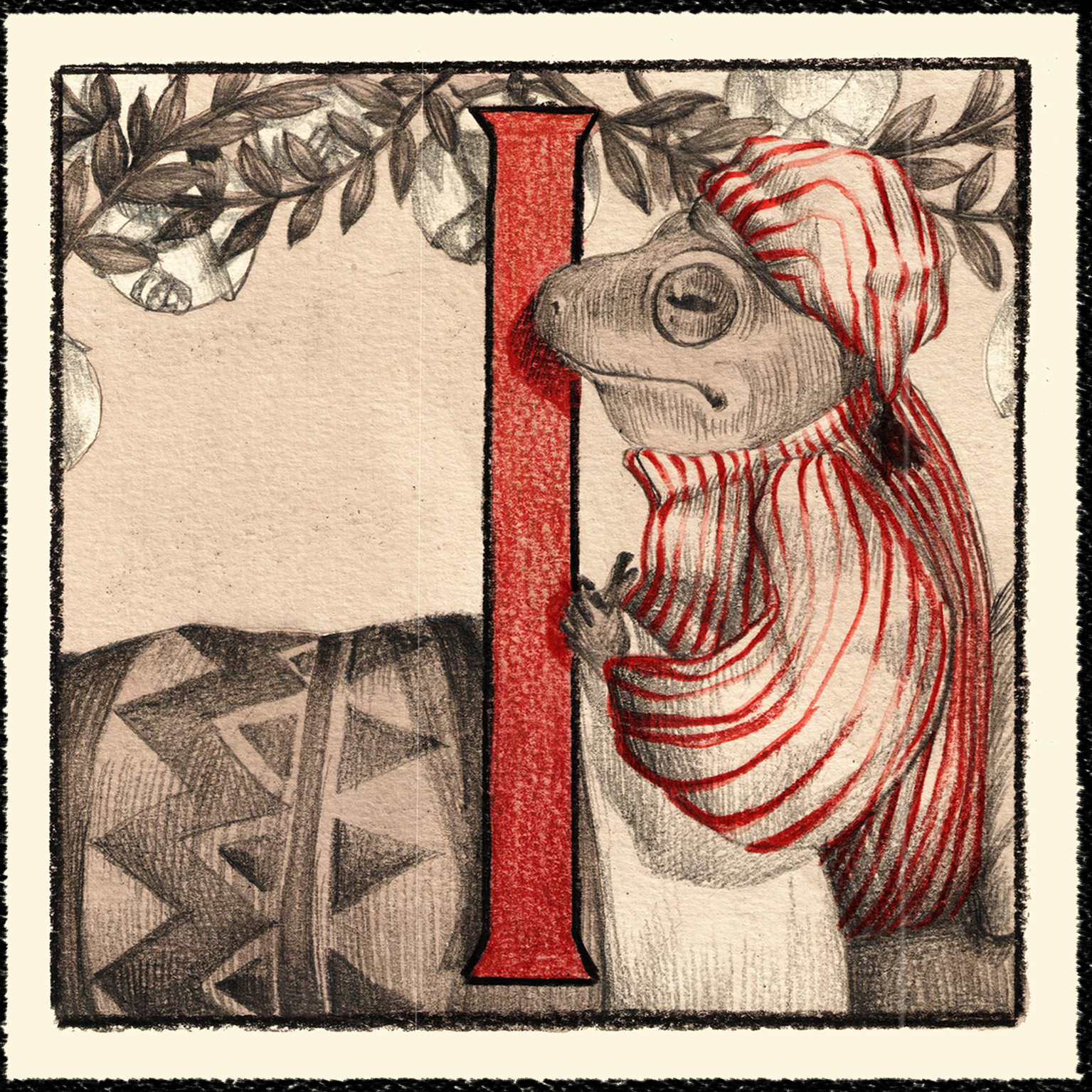
l primo aggettivo che mi è saltato in mente quando a lezione di Psichiatria la professoressa ci ha chiesto cosa pensassimo dell’approccio umano alle malattie psichiatriche è: limitato. Patologie che spesso molti inquadrano come meri “disturbi dell’anima” e di cui, ancora più spesso, si ignora l’eziopatogenesi genetica e organica, che si arricchisce di fattori ambientali, né più né meno di una qualunque altra malattia. La scoperta di altre patologie, tuttavia, è più semplice da “metabolizzare”, perché le loro cause e i loro effetti risiedono in un’area più o meno limitata del corpo piuttosto che nei meandri bui e imprevedibili del cervello. La malattia psichiatrica, così, diventa quella più temibile semplicemente perché meno conosciuta e stigmatizzata da secoli di pregiudizi. Quando poi il disturbo in questione prende il nome di “schizofrenia” il pregiudizio diventa paura, terrore, e anzi peggio: fuga.
Che cos’è la schizofrenia? Stando ben lungi dalla dicotomia che associa la schizofrenia all’isteria, definiamola per quello che è. La schizofrenia è una psicosi cronica caratterizzata dalla persistenza di sintomi di alterazione delle funzioni cognitive e percettive, con un decorso superiore ai sei mesi e con forte disadattamento della persona, ovvero una gravità tale da limitare o compromettere le normali attività di vita. I sintomi clinici comprendono: deliri, allucinazioni visive e/o uditive, eloquio e comportamento disorganizzato, abulia a cui spesso si associa mancanza di relazioni sociali. È una delle patologie psichiatriche più gravi e prima del XIX secolo non era riconosciuta come malattia: gli schizofrenici erano considerati delinquenti o deviati.
Quando nell’Ottocento nacque la Psichiatria, con essa nacquero i manicomi. Ma sebbene il cammino che portò alle conoscenze di cui disponiamo ora vide controversie e spesso terapie e approcci disumani, oggi sappiamo che la schizofrenia può essere controllata. Certo è che in un percorso tanto particolare quanto difficile come quello della cura di questa malattia è imprescindibile il lavoro sinergico tra il medico, il paziente e la sua famiglia. Potrebbe sembrare una frase fatta, ma la realtà ci dimostra che in un tempo non molto lontano questo concetto non veniva accolto con grande compliance; i familiari dei pazienti, ricoperti dalla vergogna e spesso nel silenzio generale, relegavano i propri cari in manicomi da cui sapevano che non sarebbero usciti mai, occultati perché marchiati da quella che veniva considerata una “strada senza ritorno”. La pena per essere “uomini deboli, dominati dagli spiriti” era quella di essere condannati alla detenzione in queste strutture insieme a compagni di sventura con malattie delle più disparate, in un contesto quotidiano perennemente a contatto con disturbi di ogni altro genere. È intuitivamente semplice immaginare che mai se ne sarebbe potuti uscire “guariti”: al massimo più vulnerabili di prima.
Nell’immaginario collettivo, poi, la figura del medico e degli operatori sanitari in tali contesti è emblematica: ci hanno propinato film su film in cui risalta su tutti la figura del dottore (pazzo anche lui) crudele e deviato, che tratta l’uomo non come uomo ma come cavia, condannandolo alla regressione. Il tutto in una danza lugubre di ombre e urla provenienti dalle altre “celle” di prigione, in ospedali horror magari su isole ai confini del mondo e in contesti quasi senza tempo e spazio, così lontani dalla “vita normale” per farne dimenticare agli altri l’esistenza. (Avete visto Shutter Island?)
La difficoltà di ammetere i propri limiti è sempre stato il più grande limite dell’uomo: ammettere che la propria coscienza è compromessa è quasi insostenibile. Le idee che ci facciamo sulla mente (o psiche) ci toccano molto da vicino, perché investono le radici della nostra identità. Inoltre, le conoscenze scientifiche sulla natura dei disturbi e sulla salute mentale non sono certe. La mente è forse troppo grande per essere esplorata nella sua interezza, i circuiti che ne regolano il funzionamento, poi, non possono essere paragonati a nessun altro del corpo, la diversità degli individui è notevole, sembrerebbe un pozzo senza fondo. E si sa, mai come nell’ignoranza si insinuano tanti pregiudizi; essi sono i primi strumenti – quasi una piccola teoria già pronta basata su luoghi comuni – con cui riempiamo queste incertezze e difendiamo istintivamente noi stessi.
Il pregiudizio estremizza, generalizza, rifiuta l’analisi. Dà un senso immediato di sicurezza perché rende più semplici realtà complesse e poco conosciute. Tutti, indipendentemente dal livello di cultura e dalle capacità intellettuali, possiamo usare il pregiudizio come una scorciatoia di pensiero, sia se riflettiamo su noi stessi che sugli altri.
E quando c’è una sofferenza mentale il pregiudizio si accentua. La sofferenza mentale è una realtà scomoda, su cui si preferisce tacere. Così ai tanti problemi della sofferenza si aggiunge anche quello del silenzio, uno schermo pesante e opaco che allontana chi soffre dal mondo, e non a caso è stato evidenziato che i pazienti psichiatrici sono quelli che con più riluttanza vanno dal medico e che con maggiore probabilità rifiutano la diagnosi e che col tempo non sono aderenti alla terapia.
Il paziente psichiatrico, come tutti i pazienti, è dotato di emozioni e aspettative sull’esito della terapia, ma nel caso di alcune gravi patologie come la schizofrenia può rendersi difficile l’instaurarsi di una relazione medico-paziente sufficientemente collaborativa. I pazienti affetti da schizofrenia sono spesso privi di insight (la consapevolezza cognitiva della loro patologia); in tale contesto il livello di auto-riflessività si riferisce ai processi cognitivi coinvolti nella presa di coscienza delle loro esperienze anomale (allucinazioni) e delle loro interpretazioni sbagliate (deliri). Per capirci immaginate che tutto quello che vi sta intorno sia messo in discussione da un omone in camice che vi dice: «Sua moglie è solo frutto della sua immaginazione, questo suono in realtà non esiste»: come reagireste? (Avete visto A Beautiful Mind?)
Nel delizioso libro La luna nel pozzo, lo psichiatra Luigi Cancrini, un uomo che ha dedicato la sua vita alla cura della persona prima ancora della malattia in sé, tratta del disturbo schizofrenico cercando di dare una nuova e stimolante interpretazione del coinvolgimento degli operatori per una valutazione dei fattori interpersonali che stanno alla base della malattia.
A partire dal contesto di una comunità terapeutica in cui i pazienti raccontano le loro storie in anni di percorso, vengono studiate le relazioni tra operatori e famiglia evidenziandone un fenomeno definito “controtransfert”. Si tratta di una distorsione delle relazioni che pazienti, familiari e terapeuti stabiliscono l’uno con l’altro, basata su bisogni difensivi del gruppo, su miti familiari e su come tutto ciò viene accolto dagli operatori, in una sinossi intricata e interessante. Luigi Cancrini prende spunto da ciò per formulare una teoria del disturbo schizofrenico basata sulle recenti scoperte nell’ambito della psicanalisi e della terapia familiare sistemica: presenta un’ipotesi originale su un percorso ineluttabile e nero, un pozzo per l’appunto, in cui però comincia a scorgere la luce della luna: una speranza verso la conoscenza e un passo per perseguire una verità di cui non si può più aver paura.
Nella letteratura la cosiddetta “follia” e la malattia mentale hanno ispirato non solo il lavoro ligio e professionale di esperti del settore ma hanno dato voce ad animi geniali e tormentati che ne hanno subito la presenza. Alcuni di essi sono Charles Baudelaire, “il poeta maledetto”; Dino Campana, autore dei Canti Orfici che fu ripetutamente internato in manicomio; Edgar Allan Poe, la cui morte i giornali spiegarono come una “congestione del cervello”; Virginia Woolf, vittima di crisi depressive e profondi esaurimenti nervosi; Van Gogh, che si tolse la vita dopo aver dipinto il capolavoro Campo di grano con volo di corvi; e la meravigliosa Alda Merini.

C’è un dipinto di Jean-Léon Gérôme che considero la rappresentazione visiva più impattante e vicina a ciò che ho scritto. Una donna nuda e stravolta, scompigliata e con una sorta di frustino in mano, esce dal fondo di un pozzo. Sicuramente potrebbe apparire una visione terribile, ma affascinate e bellissima insieme. Potremmo pensare a una strega, a un animo tormentato che riemerge dagli inferi per punirci, invece personifica qualcosa di più sconcertante e reale: la Verità. In questa donna che fissa lo spettatore senza incertezza, ma con furia e determinazione, Gérôme rappresenta la Verità che esce dal fondo dell’anima, o della coscienza, armata, per colpirci e scuoterci, nuda perché non ha bisogno d’altro. La bocca spalancata in un richiamo, perché non si può scappare da lei che è intenzionata a raggiungerci.
di Gemma Osso
Leggi tutti gli articoli del numero 21




