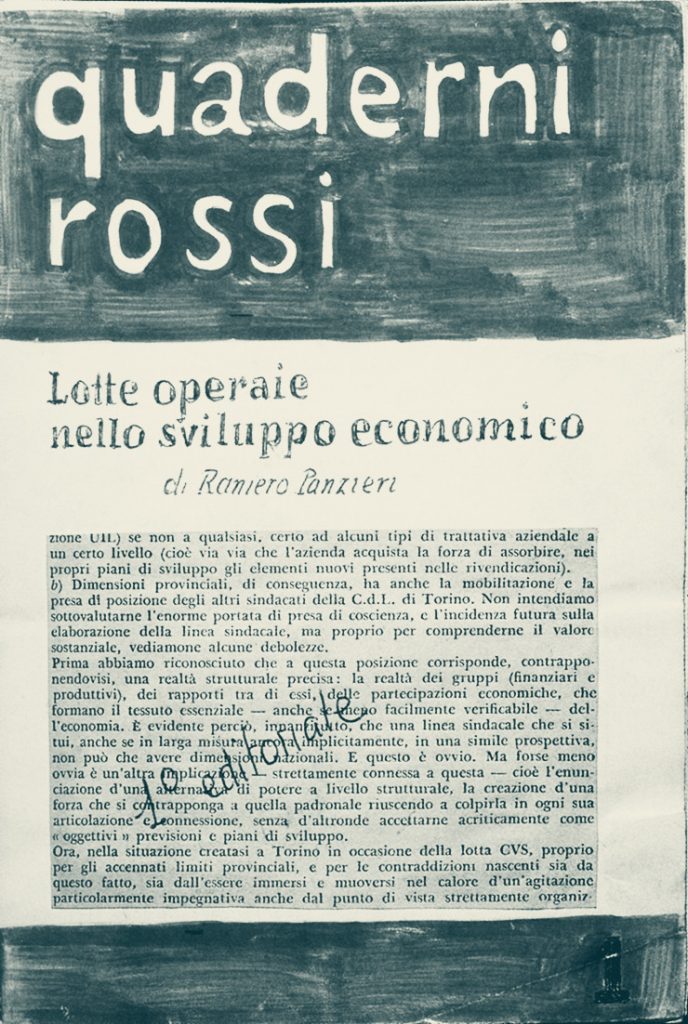Il movimento italiano del ’68 non nacque dal nulla. Quell’incredibile «ondata rivoluzionaria e creativa, politica ed esistenziale»[1] che investì il mondo intero rivendicando l’impossibile come orizzonte programmatico d’azione, conobbe in Italia un lungo periodo di gestazione durato circa dieci anni.
Ricostruire anche solo a grandi linee la storia delle lotte e dei movimenti politico-culturali che attraversarono il Paese durante tutti gli anni Sessanta eccederebbe i limiti di questo articolo[2]. Piuttosto vogliamo aprire un piccolo scorcio su un frammento, importante, di quella galassia. Stiamo parlando dei Quaderni Rossi, una rivista nata su impulso di Raniero Panzieri nel 1961.
Prima però facciamo un passo indietro.
Siamo negli anni Cinquanta. Il cosiddetto miracolo economico è ancora di là da venire e la società italiana è scossa da un profondo processo di ristrutturazione capitalistica. La riforma agraria che timidamente sembrava prendere forma nel 1944 coi decreti Gullo già nel 1948 viene affossata da Antonio Segni, ricco proprietario terriero sardo che succedette a Gullo come ministro dell’Agricoltura e restituì le terre ottenute dai contadini agli antichi padroni. Dalle campagne, soprattutto quelle del Meridione, milioni di persone si muovono verso le città. Tre sono le mete più gettonate: Milano, Torino, Genova, il triangolo industriale.
Ma sono anni difficili questi per la classe lavoratrice. La ristrutturazione capitalistica significa lacrime e sangue per i lavoratori. E non parliamo soltanto dei contadini espulsi dalle terre. Nelle fabbriche la parola d’ordine è «ristabilire il principio di autorità». Lo dice chiaramente Vittorio Valletta, capo della Fiat, in un memoriale diretto alla diplomazia USA datato gennaio-febbraio 1954:
È nota la facilità di manovra lasciata agli attivisti comunisti in Italia ed in altri paesi europei subito dopo la liberazione (1945-1946), presa di possesso da parte degli attivisti comunisti di quasi tutti i posti chiave delle varie organizzazioni operaie e di lavoro […].
Alla Fiat la lotta nei confronti di tali attivisti comunisti per la rigenerazione, oltre che dell’insieme dell’azienda, dei quadri e degli operai, si è appunto iniziata col 1946 ed è continuata da allora ininterrottamente fino ai giorni nostri.
Lo sviluppo di tale lotta ha avuto per base […] la ricostituzione del principio di autorità nelle officine, provvedendo al licenziamento di quegli elementi faziosi, desiderosi di turbare il libero svolgimento del lavoro e di creare dei disordini[3].
Il primo passo per rilanciare l’economia è dunque la rottura di ogni forma di resistenza allo sfruttamento. E lo sfruttamento è, negli anni Cinquanta, bestiale. Le condizioni di lavoro e di esistenza della maggioranza dei proletari peggiorarono drasticamente. La segretaria dei tessili della CGIL, Teresa Noce, per esempio,
ricordò, nel 1951, che mentre vi erano stati investimenti assai scarsi per le nuove macchine, si chiedeva a tre operai di fare il lavoro di otto, l’orario giornaliero ammontava spesso a 12-15 ore, ed era drammaticamente aumentato l’impiego di ragazzi sotto i quattordici anni[4].
Quello del tessile non era un’eccezione.
Le piccole fabbriche, che negli anni ‘50 erano in continuo aumento, furono ancora più libere nell’imporre le proprie condizioni. L’assenza del sindacato significava qui scarso controllo sui livelli salariali, sui lavori pericolosi, sul pagamento dei contributi. Man mano che le piccole aziende prosperavano, le differenze salariali, che erano state notevolmente ridotte alla metà degli anni ‘40, cominciarono nuovamente ad ampliarsi, con una crescente penalizzazione dei livelli più bassi. Se si prende in considerazione anche l’aumento del lavoro a cottimo svolto in casa dalle donne (guanti, stringhe, vestiti, giocattoli, ecc.), il peggioramento della condizione salariale appare sempre più evidente[5].
Alla repressione di fabbrica si accompagna la repressione politica. «Il bilancio […] a partire dal luglio al luglio 48 alla fine del 50 è di 62 uccisi, 3.126 feriti e 92.169 arrestati per motivi politici (di cui 19.306 condannati a complessivi 8.441 anni di carcere)»[6]. A questi dati, tratti dalla Fondazione Cipriani, fa eco Andrea Villa, nella voce Il miracolo economico italiano dell’Enciclopedia Treccani:
Ancora più impressionante risulta il numero dei lavoratori che furono coinvolti nella dura repressione con cui le forze di polizia, guidate dal ministro degli Interni Mario Scelba (1901-1991), contrastarono gli scioperi. Per aver partecipato a manifestazioni sindacali, tra il 1948 e il 1954 vennero uccisi 75 operai, 5104 furono feriti e circa 150.000 arrestati (di questi ultimi, 61.200 vennero condannati)[7].
Nella sola provincia di Bologna i dati
riportano 2 morti e 773 feriti in scontri con la polizia tra l’aprile 1948 e il maggio 1954. Ci furono 13935 processi di resistenza alla forza pubblica, 7531 dei quali si conclusero con un verdetto di colpevolezza. Tra questi vi furono 4729 condannati per “invasione di terreni”, ma anche 670 per aver venduto “l’Unità” per le strade, 1086 per aver affisso manifesti, 338 per partecipazione a riunioni e assemblee politiche, 61 per occupazione di fabbrica[8].
La Repubblica democratica fondata sul lavoro non fu, per i lavoratori, poi così democratica…
A questa dura offensiva padronale le organizzazioni operaie, in particolare il PCI e il PSI, non seppero opporre alcun argine. Del tutto imbevute dell’ideologia “ricostruttivista” – secondo cui era innanzitutto necessario collaborare con la borghesia italiana alla ricostruzione del Paese prima di pensare a qualsivoglia forma di lotta per nuovi rapporti sociali –, non soltanto non seppero elaborare una difesa coerente e organizzata degli spazi di autorganizzazione conquistati dalla classe lavoratrice durante la guerra (durante la fase finale del conflitto le fabbriche del Nord erano sostanzialmente confiscate e autogestite dagli operai), ma cooperarono per smussare le lotte dei lavoratori e per far passare le ristrutturazioni imposte dalle dirigenze aziendali. È in questo clima che maturò la drammatica sconfitta della CGIL alle elezioni sindacali del 1955, quando il sindacato più conflittuale in Italia, per la prima volta dal dopoguerra, perse la maggioranza nelle commissioni interne della Fiat.
È in questo clima che però contemporaneamente matura la riflessione critica di un dirigente dell’ala sinistra (detta morandiana dal nome del suo dirigente: Rodolfo Morandi) del PSI: Raniero Panzieri. Panzieri è un giovane quadro del partito. Nato nel 1921 si è impegnato nelle lotte contadine nel sud Italia già nell’immediato dopoguerra: «nel 1951 è processato assieme ad altri compagni per istigazione di contadini all’occupazione di terre e per l’occupazione stessa»[9]. Negli stessi anni traduce insieme alla moglie il secondo volume del Capitale di Marx, oltre a tenere una serie di corsi di filosofia in università. Candidato, alla morte di Morandi, a succedergli come uno dei massimi dirigenti del PSI, verso la fine degli anni Cinquanta, per la precisione nel 1959, si consuma invece la rottura tra Panzieri e il partito.
Le ragioni di questa rottura ruotano attorno precisamente alla funzione del partito nelle lotte operaie che si agitano in quei decenni. Panzieri imputa al PSI una strategia fondamentalmente concertativa, fatalista nelle «magnifiche sorti e progressive» dell’industrializzazione, incapace di produrre una reale politica autonoma della classe lavoratrice e quindi, in definitiva, di costruire un’alternativa all’attuale società.
Perché viceversa si concretizzasse un processo di autonomizzazione della classe lavoratrice, secondo Panzieri, era innanzitutto necessario che si rimettesse in discussione proprio le radici teoriche dei partiti operai, a partire dalla fede che dimostravano nei confronti dello sviluppo tecnologico in ambito capitalistico. Proprio questo sarà il punto di partenza delle riflessioni che scaturirono nei Quaderni rossi.
Nati nel 1961, fin da subito si imposero sulla scena teorico-politica come un punto di riferimento. Il primo numero venne stampato in decine di migliaia di copie (circa 70 mila) e produsse un’impressione ben superiore alle aspettative dei suoi creatori. Alcuni dei maître à penser che, nel bene o nel male, tengono tutt’oggi banco si formarono proprio nei Quaderni Rossi: da Cacciari a Tronti, da Negri ad Asor Rosa…
Oltre all’oggetto delle proprie riflessioni, la critica al fatalismo dei partiti operai, ciò che caratterizzò fin da subito i Quaderni rossi fu l’innovativo metodo di indagine, definito da uno dei suoi inventori, Romano Alquati, “conricerca”. Di fondo la conricerca esprimeva l’impellenza degli autori dei Quaderni unire teoria e prassi in un unico processo. Un processo che non schiacciasse un aspetto sull’altro, come spesso capita, ma che fosse capace di valorizzare tanto la teoria quanto la prassi. Perché ciò fosse possibile era necessario coinvolgere direttamente l’oggetto del proprio studio, la classe lavoratrice, entro il proprio studio. Ricercatore e ricercato diventavano così la stessa medesima cosa, creando una originale commistione teorica e organizzativa. Il lavoratore coinvolto nell’attività teorica “pura” era spronato per ciò stesso a istruirsi, a formarsi, a gettare uno sguardo complessivo sulla società. Il ricercatore, viceversa, era costretto a comprendere concretamente i processi produttivi, la divisione del lavoro nelle fabbriche, la composizione della classe lavoratrice.
Dicevamo però la critica al fatalismo. Il testo più significativo che si può prendere in esame è senza dubbio il saggio di Panzieri uscito già sul primo numero della rivista: Sull’uso capitalistico delle macchine nel neocapitalismo.
A partire da una rilettura di un breve passo dei Lineamenti di economia politica di Marx, una serie di appunti rimasti inediti fino agli anni Cinquanta del Novecento, Panzieri opera una vera e propria rivoluzione teorica rispetto alle concezioni allora dominanti nel marxismo “ortodosso”. Lo sviluppo delle forze produttive (e quindi anche della tecnologia), dice infatti Panzieri, non è e non può essere considerato neutrale. Quindi, considerato in sé e per sé, non è in grado di preparare il terreno allo sviluppo automatico di nuove forme di relazioni sociali che superino il modo di produzione capitalistico.
Se per il PCI e il PSI era necessario, come abbiamo detto poco sopra, collaborare alla ricostruzione del Paese poiché questa era la condizione di possibilità del socialismo, per Panzieri, una ricostruzione del Paese sotto il segno dello sviluppo capitalistico non avrebbe fatto altro che rafforzare il dominio del capitale sulla società. Scrive Panzieri:
La fabbrica automatica stabilisce potenzialmente il dominio dei produttori associati sul processo lavorativo. Ma nella applicazione capitalistica del macchinario, nel moderno sistema di fabbrica «l’automa steso è il soggetto, e gli operai sono coordinati ai suoi organi incoscienti solo quali organi coscienti e insieme a quelli sono subordinati a quella forza motrice centrale». Si può stabilire, tra l’altro: 1) che l’uso capitalistico delle macchine non è, per così dire, la semplice distorsione o deviazione da uno sviluppo «oggettivo» in se stesso razionale, ma esso determina lo sviluppo tecnologico; 2) che «la scienza, le immani forze naturali e il lavoro sociale di massa… sono incarnati nel sistema delle macchine e… con esso costituiscono il potere del “padrone”»[10].
Su questo tema ritornerà in un altro saggio, intitolato Lotte operaie e sviluppo capitalistico:
Le macchine sono sempre fatte nel capitale, non sono delle invenzioni tecniche, oggettive. Dentro la macchina, diceva Marx, c’è la volontà del capitale, la macchina è plasmata dal capitale. Le macchine servono per produrre: in questo senso contengono un elemento oggettivo, per così dire ma che è commisto sempre all’elemento che deriva dal modo sociale con cui si produce. C’è un uso capitalistico delle macchine che plasma anche le macchine in un certo modo. E via via che si procede nei vari stadi dello sviluppo tecnologico […] sempre di più si qualificano le tecniche di integrazione dell’operaio[11].
Le conseguenze politiche sono dirompenti:
Nessun «oggettivo», occulto fattore, insito negli aspetti di sviluppo tecnologico o di programmazione nella società capitalistica di oggi, esiste, tale da garantire l’«automatica» trasformazione o il «necessario» rovesciamento dei rapporti esistenti. Le nuove «basi tecniche» via via raggiunte nella produzione costituiscono per il capitalismo nuove possibilità di consolidamento del suo potere[12].
Ossia, soltanto la cosciente volontà di rottura del sistema di dominio del capitale può garantire la possibilità di una rivoluzione socialista.
I Quaderni rossi durarono cinque anni. Nati nel 1961 chiusero i battenti nel 1966 dopo aver pubblicato solo sei numeri. In realtà già nel 1963 i Quaderni rossi erano diventati un’altra cosa rispetto a quella rivista che aveva visto la luce due anni prima. Una parte consistente degli autori infatti decise che i tempi erano maturi per portare avanti nuove esperienze altrove. Nel 1964, in sovrappiù, improvvisamente Raniero Panzieri morì.
Tuttavia, nonostante la breve esistenza, i Quaderni rossi seppero lasciare una traccia profondissima nel solco dei movimenti rivoluzionari italiani. Una traccia che emerse e si impose proprio a partire dall’anno in cui ebbe inizio la storia dell’orda d’oro: il 1968.
Note
[1] Per usare le parole che compongono il sottotitolo de L’orda d’oro di Primo Moroni e Nanni Balestrini.
[2] Per chi fosse interessato consigliamo la lettura del libro poc’anzi citato: L’orda d’oro di Moroni e Balestrini, uno «strumento di mémoire» (N. Balestrini, P. Moroni, L’orda d’oro 1968-1977. La grande ondata rivoluzionaria e creativa, politica ed esistenziale, Feltrinelli, Milano 2007, p. 10) che chiunque voglia comprendere quegli anni dovrebbe fare proprio.
[3] V. Foa, Sindacati e lotte operaie (1943-1973), Loescher, Torino, 1976, p. 107.
[4] P. Ginsborg, Storia d’Italia (1943-1996). Famiglia, società, Stato, Einaudi, Torino 1998, p. 222.
[5] Ivi, pp. 222-223.
[6] http://www.fondazionecipriani.it/home/index.php/approfondimenti/42-uccisi-dallo-stato (consultato il 28/05/2021).
[7] A. Villa, Il miracolo economico italiano, in “Il Contributo italiano alla storia del Pensiero – Tecnica”, Treccani, 2013 (https://www.treccani.it/enciclopedia/il-miracolo-economico-italiano_%28Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Tecnica%29/, consultato il 29/05/2021)
[8] P. Ginsborg, Storia d’Italia, op. cit., p. 223
[9] R. Panzieri, La ripresa del marxismo leninismo in Italia, introduzione di D. Lanzardo, Nuove Edizioni Operaie, Roma, 1977, p. 8.
[10] R. Panzieri, Sull’uso capitalistico delle macchine nel neocapitalismo, in Lotte operaie e sviluppo capitalistico, a cura di S. Mancini, Einaudi, Torino 1976, pp. 5-6.
[11] R. Panzieri, Lotte operaie e sviluppo capitalistico, in ivi, p. 36.
[12] R. Panzieri, Sull’uso capitalistico delle macchine nel neocapitalismo, in ivi, p. 7.