
A guerra finita tutti i prigionieri avevano il proprio brandello di verità da raccontare. Tutte le possibili forme di comunicazione letteraria furono consumate in una smania di narrazione che travolgeva il paese intero. Per molti, raccontare fu il riflesso di un fisiologico bisogno di ricapitolazione di quegli anni convulsi. Il primo a rendersene conto fu proprio un prigioniero, Vittorio Sereni.
Le sofferenze materiali e maggiormente quelle morali non ci consentono più di dedicarci ad alcune attività come nei primi tempi: lo studio non attira più, non rende più: il lavoro normale diviene impossibile, i libri delle biblioteche sono stati letti 3 o 4 volte. Ci si sta abbruttendo in modo tale che molti di noi non potranno più concludere niente al loro ritorno a casa. La malaria, l’ameba dilagano mentre i casi di pazzia sono in continuo aumento e i casi di sincope sono tra i più frequenti…Ci tolgono brandelli della Patria, siamo in una condizione disperata… il nostro Governo si faccia sentire. [1]
Così scriveva nel gennaio del ’46 al capo dello stato un contingente italiano recluso in Kenya, disilluso di fronte al continuo rinvio della data di rimpatrio. I prigionieri di guerra italiani nella Seconda Guerra Mondiale, circa mezzo milione, divennero al termine del conflitto un fattore rilevante all’interno dello scacchiere politico italiano. Rastrellati sui vari fronti dove andava consumandosi la disfatta dell’esercito fascista e sparsi poi sui campi di internamento disseminati per tutto il globo, racchiudevano tutte le varie anime che agitavano il paese in quegli anni decisivi: fascisti, antifascisti, monarchici, repubblicani, comunisti, socialisti, anarchici. Un guazzabuglio di credo politici estremizzati dall’esperienza desolante della prigionia oltre che dal generale disinteresse della madrepatria nei loro confronti. In vista del fondamentale referendum costituzionale del ’46 infatti, sia le sinistre che la democrazia cristiana erano preoccupate dal rientro dei prigionieri. Temevano che la loro presenza orientasse il voto verso una polarizzazione insostenibile per il paese e così scelsero, deliberatamente, di escludere dal voto mezzo milione di italiani che erano stati catturati combattendo per la nazione.
La vicenda del mancato coinvolgimento nel voto del ’46 fu una ferita profonda nell’animo dei prigionieri. Per molti di loro era stato il colpo di grazia sulle speranze di rinnovamento della patria che avevano nutrito sin dall’inizio della guerra. Si trattava dell’esito di un percorso che aveva avuto il suo culmine nel conflitto civile e che attraversava il suo iter istituzionale nei mesi immediatamente successivi alla liberazione. I prigionieri sentivano così di aver mancato entrambi gli appuntamenti: da un lato non avevano potuto combattere per assicurare al paese il futuro che meritava e dall’altro non avevano potuto scegliere quale forma quel futuro avrebbe dovuto assumere. A separarli dalla storia erano, in entrambi i casi, le maglie acuminate del reticolato. Quando rientrarono, molti di loro si trovarono di fronte un paese molto diverso da quello che ricordavano. La loro giovinezza si era consumata nella guerra prima e nell’attesa dopo e non si ritrovava più nei luoghi consueti, le immagini con cui erano cresciuti si erano consumate durante gli anni. L’Italia era in macerie, divisa, prostrata dalla guerra civile e dai bombardamenti, percorsa da sotterranee vene di rancore e risentimento. E anche quando il giubilo si spargeva per le strade, i prigionieri sentivano di non farne parte, perché non avevano patito come i loro compatrioti, non avevano lottato sul suolo dei loro padri e non potevano ora partecipare ai festeggiamenti con il fervore di coloro che c’erano stati.
Questo sentimento di esclusione fece da substrato all’immensa mole di testimonianze che i detenuti produssero negli anni a venire. Per i prigionieri, però, questi racconti si caricarono del rancore accumulato in anni di sevizie. Le proprie disgrazie vennero utilizzate come uno strumento contro autorità e potere, gli organi istituzionali che li avevano abbandonati. La letteratura divenne il luogo dove finalmente esprimere la verità nascosta, riscattare le ingiustizie. Si sprecarono le produzioni che descrivevano nel dettaglio nequizie, voltafaccia governativi, miserie, oltraggi e l’angoscia patita. Non solo romanzi ma racconti, poesie, divagazioni, appunti , taccuini, diari di ogni sorta popolavano le scrivanie degli editori, tutte opere che soffrivano della stessa tragica fragilità. Quel riscatto che proponevano, per quanto giustificato, ammantava i testi di una coltre aspra, limitandone la portata comunicativa.
A tal proposito Vittorio Sereni così scriveva all’amico Alessandro Parronchi nel ’45:
Anch’io avrei da vuotare il sacco, forse, di molta bile e molte miserie. Ecco, ma io temo che tutto ciò rimanga strettamente personale, un risentimento da prigioniero. E Dio sa quanti diari di prigionia ci affliggerà il dopoguerra […]. Non saper resistere a questa forma di risentimento è la mia più grande preoccupazione[2].

Il poeta di Luino non era estraneo al sentire degli altri reclusi. Anche lui avvertiva il bisogno spasmodico di raccontare l’esperienza capitale della guerra, sofferta e distante per intenti, lo straniamento del trasferimento in Grecia ma soprattutto l’attesa, il senso di inutilità patito prima ad Atene e poi soprattutto nei campi di Orano e Casablanca. Lui stesso era stato richiamato alle armi sotto la Divisione Pistoia nel ’41 e destinato qualche mese dopo a congiungersi con un battaglione italiano stanziato in Africa, attraverso appunto la Grecia. La disfatta di El Alamein però sconvolse i piani, costringendo la divisione a un prostrante stallo di quattro mesi ad Atene, culminato con il rimpatrio. Due anni dopo Sereni venne assegnato nuovamente al fronte africano. Inviato in Sicilia, il trasferimento dall’isola alle coste nordafricane di nuovo non si concretizzò, questa volta a causa della caduta di Tunisi. In compenso a luglio gli Alleati sbarcarono sulle coste siciliane e la Divisione Pistoia venne fatta prigioniera a Paceco, nei pressi di Trapani. Sereni e i suoi compagni vennero deportati prima in Algeria, dove resteranno due anni, e poi in un altro campo d’internamento in Marocco. Questi avvenimenti, segnati dalla delusione di non aver preso parte attiva all’evento decisivo della sua generazione, avevano tormentato il poeta per anni al termine della guerra. Lo racconta lui stesso nel racconto L’anno quarantatré:
Di queste cose ho già scritto varie volte in versi e in prosa: sono arrivato al ridicolo affliggendo col raccontarle amici e familiari. Mi ci sono accanito dentro di me per anni, quasi si trattasse di un enigma di cui non venivo a capo […]; quasi si trattasse di un nodo dentro di me, sciolto il quale soltanto avrei potuto avere occhi per altro, orecchi per altro[3].
La ferita della prigionia e dell’esclusione rimase aperta per tutta la vita. Come gli altri prigionieri, Sereni la trascinò con sé sempre e finì per affrontarla in prima persona nella sua produzione.
Quando aveva iniziato a raccogliere le liriche che comporranno il Diario d’Algeria, il suo intento principale era superare il risentimento che impediva alla narrazione dei prigionieri di risultare decisiva. Nel farlo, riesce a collocare sul testo un tempo artificioso, frutto delle aspirazioni mancate di un individuo che avrebbe voluto vivere e patire in altri modi gli sconvolgimenti della storia. In questo modo crea una parola che replica l’immobilità, il senso di esclusione del campo senza scadere in una forma privata o diaristica, ma innervandosi sulle emozioni pure di chi è rimasto fuori dai giochi della guerra. Già nel Natale del ’45 l’amico e poeta Attilio Bertolucci, scrivendo a Sereni, certificava il valore della raccolta:
[…] senza accorgertene stai scrivendo il diario poetico di questa guerra. E credo che anche quanto hai scritto laggiù, e mi dicevi riletto ora ti pareva meno importante, possa contenere moltissimo in quell’insieme che io vedo, e che hai il colore tuo e dei tempi[4].
La vita nel campo di Orano era sospesa, atterrita dall’annullamento di ogni progettualità. I prigionieri sentivano stringersi su di loro la morsa della storia, che li abbrancava stritolando ogni certezza. Così si erano incrinati, qualcosa in profondità si era rotto e non gli era possibile ripararlo. Il nodo che Sereni sentiva era questa distanza tra la realtà immobile della prigionia e quella della storia, che era andata concretizzandosi in un altro luogo, distante e irrecuperabile. Per i reclusi l’unica dimensione possibile era quella del futuro, la speranza che cominciasse l’ora della verità e il momento dell’azione. Ma quell’attimo decisivo non sarebbe arrivato mai. La pietra tombale, in questo senso, la pone lo stesso poeta di Luino, in occasione di nuovo di un carteggio con Parronchi risalente al ’54: «Chi riparerà la nostra situazione? Confidiamo ancora in noi stessi e nel tempo che non finisce mai»[5].
La sensazione che il futuro potesse riservare il riscatto tanto agognato era in fondo cavalcata anche dalle istituzioni politiche. Lo stesso De Gasperi in un’intervista del maggio ’46, interrogato sulla possibilità che i prigionieri fossero esclusi dalla votazione referendaria, si esprimeva in questi termini:
D’altra parte non può non tenersi presente che tra i reduci vi sono molti giovani che sono partiti avendo avuto solo l’educazione del cosiddetto clima fascista, che i reduci non hanno vissuto come noi abbiamo vissuto la tragedia del nostro Paese, e che quindi hanno bisogno di un congruo periodo di tempo per orientarsi prima di dare la loro adesione all’uno o all’altro partito politico[6].
Ma il futuro non avrebbe mai smesso di allungarsi e il tempo, dopo essersi arrestato in quel campo algerino, non sarebbe più ripartito. La condizione di prigioniero era definitiva, inchiodata nell’individuo per sempre.
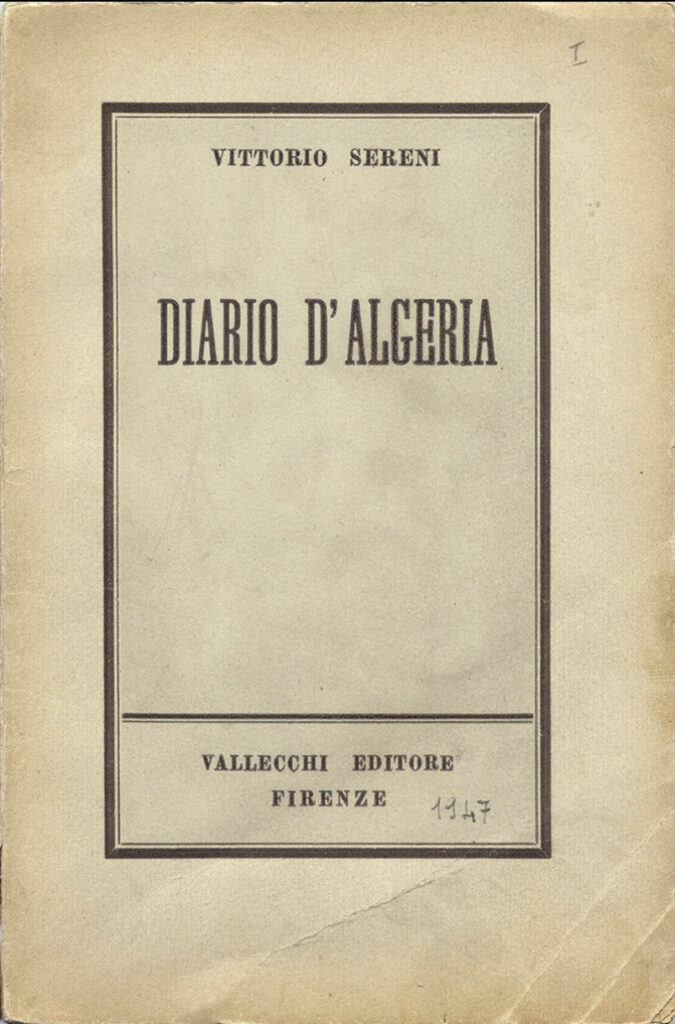
Sereni traccia perfettamente questa condizione nelle poesie del Diario d’Algeria, mettendo in scena il senso di colpa, la sconfitta, l’esclusione, la noia, l’impossibilità di vivere come di morire. In una delle composizioni più note si legge:
Ma se tu fossi davvero
il primo morto caduto bocconi sulla spiaggia normanna
prega tu se lo puoi, io sono morto
alla guerra e alla pace[7].
I prigionieri sono “morti alla guerra e alla pace”, non possono ambire né all’una né all’altra perché sono rimasti distanti dal centro pulsante della storia. Questo sentimento si estese nel dopoguerra, nella distanza tra reduci e istituzioni, tra il nuovo stato e la Resistenza, tra la speranza di costruire un paese nuovo e la consapevolezza che molti dei quadri dirigenti erano rimasti gli stessi del ventennio. La condizione del prigioniero diventava così universale, una sentenza cui era impossibile sottrarsi. In questa dimensione il recluso doveva in qualche modo cercare un riscatto, avvertiva la necessità di tornare a vivere accettando la sua condizione di escluso. Il prigioniero tentava di affrontare il suo fallimento storico attraverso gli strumenti a disposizione.
Nella precedente raccolta, Frontiera, Sereni ancora ipotizzava la possibilità di un idillio, di una vita compiuta. Il prigioniero la ricercava, interrogava sé stesso in un soliloquio che realizzasse un’assoluzione dell’individuo dalla condanna del reticolato. Ma la guerra aveva disintegrato ogni prospettiva di salvezza. Scrive al riguardo Bo: «Fino a quel momento Sereni si era illuso di imporre lui un senso al discorso mentre adesso cominciava ad accorgersi che il discorso gli ritornava addosso ma impregnato dalla muta presenza dell’altro»[8].
L’altro era l’antitesi del prigioniero, colui che non era rimasto escluso. Chiunque fosse riuscito a compiere il suo destino prendendo parte al momento topico della sua generazione rappresentava un ideale alter ego del recluso, un interlocutore che s’intrometteva nel suo soliloquio. L’altro era colui che, avvolto dalle spire della storia, poteva morire alla guerra o alla pace. Nelle poesie di Sereni questa alterità si incarna nel personaggio di Dimitrios:
Alla tenda s’accosta
il piccolo nemico
Dimitrios e mi sorprende,
d’un uccello tenue strido
sul vetro del meriggio[9].
Nelle poesie il ragazzino greco si tramuta di volta in volta nell’immagine del nemico, dell’avversario, di colui che non è rimasto impigliato nelle maglie del reticolato. La vera scissione è infatti tra chi ha potuto combattere e partecipare, nel bene o nel male, alla liberazione del paese e chi ne è rimasto escluso. Questa frattura è resa ancora più dolorosa dal passato comune che unisce i reclusi e gli altri, il tempo prima della prigionia in cui un’intera generazione condivideva aspirazioni e furori. Ma l’esperienza della guerra frantuma il sodalizio precedente e il senso di colpa acuisce lo iato tra amici e fratelli, quello scarto tra chi prima era una cosa sola. Ne parla con molta franchezza lo stesso Sereni in una breve raccolta di racconti pubblicata postuma, nell’86, intitolata per l’appunto Senza l’onore delle armi:
Si complicava già da quel momento il futuro rapporto con gli altri, protagonisti o meno dell’ora mancata e irrecuperabile. E anche loro, gli amici di prima, la gente frequentata prima, quelli con cui si poteva supporre di riprendere i discorsi interrotti da tanto tempo […] semplicemente quei discorsi erano finiti, qualunque essi fossero, loro ne stavano facendo un altro e noi eravamo lì solo con qualche stralcio inutilizzabile dei discorsi di prima[10].
La distanza tra i prigionieri e gli amici di prima è la stessa che il poeta avverte tra il sé partito alla guerra e quello che ne è tornato. Il dolore matura attraverso il mutamento della realtà intorno, adesso corrotta dalla guerra anche in quegli spazi del ricordo che Sereni riteneva inviolabili. Le promesse della giovinezza, lo slancio vitale che permeava i luoghi teatro della sua vita vengono disgregati. In questo senso sono particolarmente indicative le prime liriche del Diario, come Periferia 1940:
La giovinezza è tutta nella luce
d’una città al tramonto
dove straziato ed esule ogni suono
si spicca dal brusio.
E tu vita mia salvati se puoi
serba te stessa al futuro
passante e quelle parvenze sui ponti
nel baleno dei fari[11].
Milano appena intravista dal treno diventa un luogo vuoto, caratterizzato da parvenze sui ponti e dove ogni suono appare esule e straziato. Il Sereni che parla cova un’assenza insopprimibile, che il prigioniero è condannato a trascinarsi dietro come un macigno per il resto della sua esistenza. Gli eventi sono già scoppiati, altrove, lasciando negli esclusi senso di colpa e rimorso, oltre all’impressione di un tempo che non è più possibile recuperare. Le istantanee colte dal finestrino del treno immortalano un cambiamento radicale di prospettiva e interpretazione del reale. Incarnano una nuova modalità di esistenza, la prigionia, che non si arresta una volta fuori dal reticolato. Il tempo è ora cristallizzato in un non tempo, circoscritto in un perimetro senza importanza. Scrive lo stesso Sereni:
Il nostro dramma collettivo, incomparabilmente piccolo rispetto a quanto avveniva nel mondo, era tutto qui. In piena coscienza bisogna dire che nessuno stato di detenzione è stato più blando del nostro, di noi caduti in mano americana. I vari drammi individuali maturati in rapporto a quella situazione sono un altro discorso. Ma il nostro vero guaio era lì. In quella blanda, torpida, semidillica prigionia. Immaginando la sorte di altri amici e conoscenti (il tale sarà finito in Germania, il tal altro internato in Svizzera, quell’altro ancora scaraventato in Siberia o dalla parte degli Urali) e ripensando ai discorsi, al modo di essere, al passato comportamento di questo o di quello, conclusi che ognuno ha la prigionia che si merita[12].

Il tempo diventa il luogo in cui il prigioniero si macera nel confronto con altri meno fortunati di lui. Il privilegio diventa in questo caso uno stigma per coloro i quali non hanno patito quanto i compagni, è una condanna irrevocabile. Il tempo di prigionia non riscatta niente, né le sofferenze del popolo italiano, né quelle di amici e fratelli con cui il destino è stato meno clemente. L’inazione, il blando regime di detenzione toccato in sorte a Sereni lo relega in un tempo sperperato, senza senso. Il poeta giunge a percepire la propria come una situazione appartenente all’assurdo, come confessa all’amico Parronchi:
Vivo qui nella mia assurda situazione, tra notizie vaghe e spesso allarmanti che vengono dal Nord. Ma da casa niente. Mai come ora ho avuto il senso del tempo sperperato, degli anni regalati agli altri. Scrivi. Ti abbraccio – Vittorio[13].
Il poeta si sente letteralmente “in credito di anni”. Nel Diario leggiamo:
– Siamo noi, vuoi capirlo, la nuova
gioventù – quasi mi gridi in faccia – in credito
sull’anagrafe di almeno dieci anni…
Portami tu notizie d’Algeria –
quasi grido a mia volta – di quanto
Passò di noi fuori dal reticolato,
dimmi che non furono soltanto
fantasmi espressi dall’afa,
di noi sempre in ritardo sulla guerra
ma sempre nei dintorni
di una vera nostra guerra… se quanto
proliferò la nostra febbre d’allora
è solo eccidio tortura reclusione
o popolo che santamente uccide[14].
Il tempo sperperato diventa teatro di un’esistenza ai minimi termini, sempre nei dintorni di una guerra ma anche di un vero significato. Il delirio confonde al punto da generare fantasmi, provocati forse da una febbre d’allora, che in qualche modo slabbra i confini del reticolato e squarcia il concetto stesso di spazio. Non può esistere spazio in cui il prigioniero trovi collocazione, i luoghi sono tutti deformati dal senso di colpa. Nel Diario troviamo numerosi riferimenti al termine “casa”, con la sua topologia e i suoi elementi (la “stanza” o la “finestra”):
Inquieto nella tradotta
che ti sfiora così lentamente
mi tendo alle tue luci sinistre
nel sospiro degli alberi.
Mentre tu dormi e forse
qualcuno muore nelle alte stanze
e tu giri via con un volto
dietro ogni finestra – tu stessa
un volto, un volto solo
che per sempre si chiude[15].
La Milano qui dipinta si ritrae dal poeta, diventa un volto solo che per sempre si chiude. Non è più possibile ritrovare casa, il senso di calore e appartenenza teorizzati in Frontiera. Quello che rimane è il rifugio, la dimensione spirituale di chi è senza luogo. La precarietà, il senso di sospensione che coglie il prigioniero si traduce così in un nuovo lessico. Iniziano ad affiorare parole come “giacigli”, “marmitte”, “tende”.
Un improvviso vuoto del cuore
tra i giacigli di Saint-Barbe.
Sfumano i volti diletti, io resto solo
con un gorgo di voci faticose.
E la voce più chiara non è più
che un trapestio di pioggia sulle tende,
un’ultima fronda sonora
su queste paludi del sonno
corse a volte da un sogno[16].
La dimensione del rifugio risuona in questi versi, in cui il poeta di Luino immortala il flusso di pensieri di un prigioniero. Quando sfumano i volti diletti e si viene colti da un improvviso vuoto del cuore tra i giacigli, il passato che si allontana trascina con sé anche l’idea di casa, di radici, di stabilità e di un posto nel mondo. In questa condizione si insinua la solitudine, che rende impossibile la comunicazione poiché la voce più chiara non è più che un trapestio di pioggia sulle tende, un fruscio della natura che risulta meno opprimente delle parole degli altri, così distanti e incomprensibili da sbiadire in un gorgo di voci faticose. Cogliendo questa verità, Sereni restituisce il ritratto più fedele della condizione del prigioniero e, per estensione, di una generazione che in quei testi poteva riconoscersi. La poesia di Sereni illumina un angolo di guerra ancora inesplorato, fornendo una prospettiva nuova su un argomento difficile da comprendere fino in fondo. Il diario d’Algeria tenta di rompere la scorza della solitudine dei prigionieri e riesce nel suo intento, consentendo a chi aveva scampato quella condanna di comprendere meglio i sentimenti dei reclusi. Sbarazzandosi della bile, dei rancori repressi nei lunghi anni chiuso nel reticolato, Sereni crea un luogo di condivisione dove ritrovare uno squarcio di storia dimenticata. Un ulteriore tassello per capire fino in fondo la condizione dei prigionieri di guerra e riscattare le loro sofferenze.
Questo avevo da dire
Questo groppo da sciogliere
Nell’ultimo sussultò di gioventù
Questo rospo da sputare,
ma a te buona fortuna e buon viaggio
borbotta borbotta la pentola familiare[17].
[1] Flavio Giovanni Conti, I prigionieri di guerra italiani 1940-1945, Il Mulino, Bologna 1986, p. 154.
[2] Laura Barile, Sereni, Palumbo, Palermo 1994, pp. 37-38.
[3] V. Sereni, L’anno quarantatre in Vittorio Sereni: Poesie e prose, Mondadori, Milano 2013, p. 631.
[4] Attilio Bertolucci, Una lunga amicizia, in Apparato critico e documenti a cura di Dante Isella, in Vittorio Sereni, Poesie, Mondadori, Milano 1995, p. 437.
[5] Vittorio Sereni – Alessandro Parronchi, Un tacito mistero. Il carteggio Vittorio Sereni – Alessandro Parronchi (1941 – 1982), Feltrinelli, Milano 2004, p. 45.
[6] Alcide De Gasperi, Rieducare i prigionieri?, «La voce del prigioniero», 15 maggio 1946.
[7] Vittorio Sereni, Diario d’Algeria, Einaudi, Torino 1998, p. 22.
[8] Carlo Bo, Parlando di Vittorio Sereni, in «Letteratura», 82-83, luglio-ottobre 1966, p. 10.
[9] Vittorio Sereni, Diario d’Algeria, cit., p. 10.
[10] Vittorio Sereni, Senza l’onore delle armi, All’insegna del Pesce d’Oro, Milano 1986, p. 42.
[11] Vittorio Sereni, Diario d’Algeria, cit., p. 5.
[12] Vittorio Sereni, Senza l’onore delle armi, cit., pp. 36-37.
[13] Vittorio Sereni – Alessandro Parronchi, Un tacito mistero. Il carteggio Vittorio Sereni – Alessandro Parronchi (1941 – 1982), cit., p. 41.
[14] Vittorio Sereni, Diario d’Algeria, cit., p. 39.
[15] Ivi, p. 6.
[16] Ivi, p. 20.
[17] Ivi, pp. 39-40.
Di Luca Biondo
Leggi tutti i nostri articoli di letteratura




