La pazzia teatrale di Giovanni Battista Neri

Non credo verrà mai quel giorno in cui, passeggiando le strade di Bologna, ci sarà dato in sorte d’imbatterci in una targa, una statua, un monumento alla memoria di Giovanni Battista Neri. Il suo nome non si trova registrato in nessuna delle moderne storie della letteratura italiana, e anche in quelle antiche, a dire il vero, non viaggia esattamente in prima classe: sulla sua vita e la sua carriera di poeta, gli unici ragguagli che superino la riga e mezza ci vengono da un’opera erudita di fine Settecento, le Notizie degli scrittori bolognesi di Giovanni Fantuzzi[1]. Vi si dice che Giovanni Battista nacque «nel contado di Bologna» non si sa bene quando e che si laureò in medicina, ma che poi disertò la sala operatoria per darsi alla letteratura – disciplina in cui, a livello locale, dovette vantare un discreto successo: con una punta di esasperazione, il libro ci informa che in città «non si celebrava festa di santo, processione, dottoramento, o monacazione che non si vedesse una composizione del Neri». Ebbe qualche incarico politico di scarso peso, e al termine di una lunga carriera quest’uomo «di genio libero, e dato al piacere ed alla conversazione» morì spiantato nel 1726.
Sulle doti versificatorie del nostro eroe, il biografo non ha parole troppo gentili. I suoi pezzi di circostanza, nati da una «naturale disposizione» più che da un’arte vera e propria, godevano di qualche favore «fra la gente volgare», e il Neri – per quanto ne sappiamo – ebbe il buon senso di affidarli alle stampe con una certa parsimonia. Minor ritegno nell’esporsi all’altrui giudizio egli ebbe invece in tutt’altro genere letterario, cui oggi appartiene la quasi totalità delle sue composizioni superstiti: quello della poesia drammatica per musica.
Oltre a una manciata di rappresentazioni sacre destinate alla chiesa, il Neri produsse un totale di otto libretti d’opera. Il suo catalogo si apre con Il Celindo, rappresentato nel 1677 in un teatro di provincia: benché sulla paternità del testo – pubblicato anonimo – sia lecito avanzare alcuni dubbi, temo che in ultima analisi Giovanni Battista non possa essere ragionevolmente assolto dall’aver consegnato alle scene questo stroppiato esempio di incompetenza drammaturgica[2]. Faremo qui un favore al suo autore putativo se preferiremo dimenticarcene, concentrando la nostra attenzione sui sette drammi rimanenti che, liberati dalla presenza del loro scimunito fratellino, fanno agli occhi della critica assai miglior figura. Il moderno lettore ignaro delle convenzioni del teatro musicale dell’epoca sarà forse portato a contarne prima di tutto i difetti: la complessità dell’intreccio, spesso forzato e del tutto inverosimile; la stucchevole insistenza sul tema amoroso, sviscerato in tutte le sue più pacchiane declinazioni; una versificazione che in più di un luogo altro non sembra che un vago pretesto per l’intonazione musicale. Ma a chi è disposto ad accettare queste pecche come semplici e inevitabili regole del gioco, le opere di Giovanni Battista Neri hanno ancora oggi molto da regalare.

Il primo dei loro pregi è senza dubbio una fantasiosa, esuberante teatralità. Da consumato uomo del mestiere, il Neri conosceva i mille trucchi per tenere ben desta l’attenzione del pubblico lungo l’arco dei tre atti che ai tempi scandivano una rappresentazione operistica. Le trame da lui portate in scena – più o meno vagamente fondate, secondo l’usanza del tempo, su episodi storici o mitologici – sono sempre interessanti: si va dai sordidi intrighi di corte che fanno l’ossatura del Gige in Lidia (1683) alle contrastanti passioni che animano i protagonisti della Clotilde (1696), passando per una frizzante e deliziosa commedia degli equivoci, L’ingresso alla gioventù di Claudio Nerone (1692), i cui accadimenti si dipanano a partire da una stravagante festa da ballo alla corte imperiale di Roma. Curioso è anche ritrovare, in mezzo a tanta varietà inventiva, alcuni espedienti drammaturgici meno convenzionali per l’epoca, evidentemente volti a suscitare nell’uditorio il brivido di un’emozione più forte: la terribile morte del re Candaule, che nel Gige cade avvelenato in mezzo a un bosco con la schiuma alle labbra, i complicati rituali di magia nera che fanno da sfondo al Basilio re d’Oriente del 1696, o addirittura l’ombra dell’incesto che pende sull’ultimo dei titoli della lista, l’Erifile del 1697. È però in un’altra opera che la bizzarria del Neri si manifesta in tutto il suo splendore, un’opera che, già abbastanza singolare per i tempi in cui fu concepita, risulta oggi a dir poco sconcertante: Il Cleobulo, rappresentato al Teatro Formagliari di Bologna nell’agosto del 1683[3].
A differenza di tutte le altre opere del nostro autore – con l’eccezione del Celindo, del quale però avevo già detto che avrei provato a dimenticarmi – il Cleobulo fonda il proprio intreccio su un episodio inventato di sana pianta: niente richiami storici, niente riferimenti mitologici. Si tratta di un procedimento abbastanza inusuale, ma in fondo neanche troppo. Ciò di cui un librettista del Seicento non poteva fare veramente a meno, nella stesura di un’opera, era la storia d’amore, meglio se complicata da equivoci, gelosie, triangoli, che solo nell’ultima scena dell’ultimo atto si sarebbero risolti in uno scontato lieto fine. Che poi questa broda fosse allungata con accidenti storici realmente accaduti, era cosa consigliata dall’uso più che prescritta dalla teoria. Ma ecco che qui incontriamo il nostro primo problema, perché se diamo un’occhiata alla lista dei personaggi del Cleobulo così come appare nel libretto a stampa, ci accorgeremo subito di un dettaglio importante, destinato in teoria a compromettere la buona riuscita di una storia d’amore secentesca: l’assenza di personaggi femminili. E per scoprire in che modo questa particolare difficoltà autoimposta sia stata di stimolo alla creatività dal Neri, procediamo senza indugio a esaminare la trama dell’opera.

In una ben guarnita biblioteca, il vecchio Cleobulo trascorre le giornate a seguire i moti delle stelle in compagnia di Lisarco, il suo discepolo prediletto che cerca negli studi astrologici un diversivo all’ingrato mestiere di poeta. A interrompere la loro monotona routine, tuttavia, giunge improvvisa una strana profezia: a detta di Cleobulo, una particolare congiunzione astrale sarà destinata a fargli piovere sul capo onori e ricchezze a profusione grazie al matrimonio d’una sua figlia con un grande di Spagna. Il petulante Lisarco, tuttavia, oppone al giubilo dell’astrologo una ragionevole obiezione: Cleobulo non ha figlie. Sua unica prole è un ragazzo di nome Livio, che al momento, perso com’è dietro alle grazie d’una sua fidanzatina, ha ben altro a cui pensare che assecondare le manie del suo credulo genitore. Ma l’astrologo ha un bel cercare una diversa interpretazione all’oracolo del Cielo: per lui il senso del messaggio è chiarissimo, e se l’evidenza delle cose ha già fatto altri piani per il futuro, tanto peggio per lei.
CLEOBULO […] Potrò sperar che di mia figlia
Arda un grande di Spagna
E d’eccelsi imenei le dia la fé,
E in poco tempo io diventi re.
LISARCO Di qual figlia favelli?
Di Livio sol non sei tu padre? E come
Puoi figlie generar, s’ormai sei veglio?
CLEOBULO È ver. Bisogna ch’io misuri meglio.
(Si ritira a far varie figure sui libri […].)
CLEOBULO L’ho ritrovata, affé!
LISARCO Con l’applicar tutto s’intende sempre:
Coglie virtù chi la fatica semina.
CLEOBULO Forza è che Livio sia un ragazzo femina.
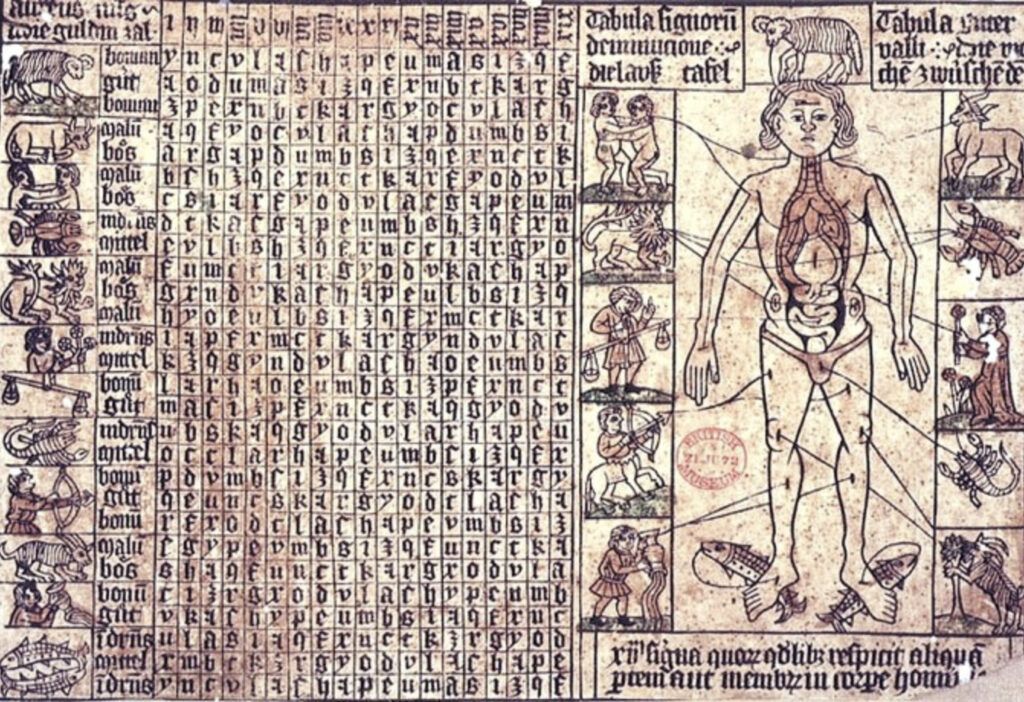
Giunto all’inoppugnabile conclusione, il piano di Cleobulo è semplice: far vestire Livio da donna, ficcargli una parrucca sul cranio e sfruttare l’ambiguità delle sue efebiche sembianze per piazzarlo nel letto di qualche nobiluomo spagnolo. Dei rimanenti dettagli dell’operazione, le stelle assicurano, la Sorte avrà buona cura.
Mentre il padre è assorbito dai suoi sogni di grandezza, il figlio è roso da tutt’altra preoccupazione. La ragazza di cui è innamorato, a causa di un certo crimine di lesa maestà commesso dai suoi famigliari, si trova ora rinchiusa nelle carceri del re in attesa di giudizio. Il delirante progetto di Cleobulo, puntualmente riferitogli da Lisarco, è accolto da Livio con una scrollata di spalle, finché nella sua mente non si fa strada un pensiero: chissà che il travestimento da donna non possa dargli modo di eludere la sorveglianza delle guardie della prigione, e aiutarlo a liberare la sua amata? Forte di questa stiracchiata speranza, il giovane accetta più volentieri l’imposta metamorfosi: gettati a terra gli abiti virili, cinti i fianchi di una gonna all’ultima moda, egli rinasce finalmente al mondo col nome di Livia. E l’occasione tanto sperata da Cleobulo, a dire il vero, non tarda a presentarsi.
Il vicino di casa di Cleobulo, un valente cavaliere di nome Diego, ha un cruccio. Vorrebbe trovarsi una brava ragazza da sposare, ma tutto preso com’è dalle sue smanie guerresche ha poca pazienza per le smancerie di rito che accompagnano un fidanzamento. Si rivolge quindi all’astrologo, sperando che le stelle abbiano qualche consiglio da dargli in proposito; ma al posto delle stelle, un consiglio glielo dà Cleobulo in persona. La sua figliola Livia – gli dice – ha esattamente lo stesso problema: di carattere fiero e indipendente, appare sempre indecisa tra il concedere la propria mano a qualche galantuomo e il voler disprezzare qualsiasi forma di legame amoroso. Diego sembra intrigato dalla descrizione, e una fugace apparizione di “Livia” nello studio del padre finisce per convincerlo del tutto: costi quel che costi, quella sarà la donna che dovrà sposare.
A far da cornice alle trame di Cleobulo, che si accinge a veder finalmente realizzati i suoi voti agli dèi, sono intanto le più concrete difficoltà di Lisarco, che si dispera perché non riesce a trovare un mecenate disposto a ricompensarlo per i suoi «poetici sudori». La sua triste condizione di poeta fallito e di astrologo credulone gli attira le frecciatine di Carillo, il paggio di Diego…
CARILLO Lisauro, e perché mai
Fra studi così vani il tempo perdi?
Sai pur che di poeti
Ne son le vie ripiene,
Ed han per premio “Oh come disse bene!”;
Ed ora con gli astrologi
Scopri il genio simpatico,
Come se tu non fossi assai lunatico.
…e i rimbrotti di Livio, cui le infinite perifrasi del vate provocano un malcelato fastidio:
LISARCO Or che a colpi di luce
Lacerata è la notte, e l’ombre uccise
Han d’Oriente insanguinato il cielo,
Mira come di raggi innalza l’Alba
Vittoriose insegne e, risonando
Duci gli augelli eco di tromba intorno,
Col sol in fronte esce in trionfo il Giorno[4].
LIVIO Tu mi stanchi l’orecchio.
E non sai dir così?
“Mira che viene il dì”.
LISARCO Questo è parlar del volgo. Alti concetti
Dee masticar chi delle Muse è figlio.
Ma le sue insistenze vengono infine premiate, e Carillo gli promette di consegnare a Diego l’ultimo dei suoi drammi in versi – una mordace satira della società contemporanea intitolata Il mondo alla moda – perché possa riceverne un adeguato compenso. La strada verso il successo, insomma, è ormai spianata, tanto per il fatuo Cleobulo quanto per l’ambizioso Lisarco. O meglio lo sarebbe, se un improvviso accidente non intervenisse a rimescolare tutte le carte sul tavolo a metà partita.

Irritato dalle attenzioni di Diego, le cui ardenti profferte si è visto costretto a respingere a suon di ceffoni, Livio decide di svestire la gonna e abbandonare il piano, malgrado le cogenti argomentazioni fornite dal padre circa le sue effettive possibilità di successo:
CLEOBULO Livio, ahimè, che facesti? Orsù, ben tosto
Tornati quelle spoglie!
LIVIO Son follie, son chimere.
CLEOBULO Così al padre rispondi?
LIVIO Diego donna mi crede, e indegni affetti
Osa svelarmi.
CLEOBULO Ecco la tua fortuna!
Giove ti cangia in femmina vezzosa,
Poscia Diego ti sposa, e diventiamo –
Stante la mia stellifica dottrina –
Egli duca, io monarca, e tu regina.
A forza di minacce e di lusinghe – e non senza prima aver imbastito una serqua di fandonie incoerenti per giustificare all’ignaro Diego i viluppi della situazione[5] – Cleobulo riesce a far desistere il figlio dall’insano proposito, ma ecco che il disgraziato «ragazzo femina» è colpito da un fulmine a ciel sereno: la fanciulla di cui era innamorato, riconosciuta colpevole di tradimento, è stata giustiziata in carcere insieme agli altri membri della sua famiglia. Il colpo improvviso, oltre a portarsi via quel poco di speranza che Livio chiudeva in cuore, ha conseguenze ancora più pesanti sui suoi fragilissimi nervi. Straziato dal dolore, il ragazzo sprofonda nella follia, spaventando a morte il paggio Carillo e crollando finalmente addormentato, vestito da donna, nel giardino di casa sua. Diego, che gli si accosta insieme a Cleobulo per corteggiare la sua “Livia”, fa quindi un’inquietante scoperta osservandone il petto attraverso le vesti strappate:
DIEGO Cleobulo.
CLEOBULO Signore?
DIEGO Livia non porta poppe?
CLEOBULO Io non lo so.
(tra sé) Maledetto il dormire e chi ‘l provò!
DIEGO Come! Donna non è?
CLEOBULO Questa licenza io non le diedi, affé.
DIEGO Olà, scherzi non voglio!
CLEOBULO Sappi che da bambina
Le tolsi la nutrice
Acciò che tanto latte
Non la rendesse una donnetta imbelle,
Così priva restò delle mammelle.
Quando Livio si desta, presentandosi nel suo delirio come la dea Fortuna scesa tra i mortali…
DIEGO Ma come? Io perdo il senno!
Vacillan le potenze,
Mi si turba la mente, io mi confondo;
Cada il ciel, pera il mondo!
Come va? Chi sei tu?
LIVIO Io son colei che sazia
Rendo ogn’alma digiuna,
E son detta Fortuna.
CLEOBULO (tra sé) Ed io disgrazia.
…Diego non trova soluzione migliore che quella di seguirlo nella sua pazzia: sguainata la spada, e inscenato un comico duello con Cleobulo armato di mappamondo, il feroce cavaliere esce di scena maledicendo tutto e tutti. Cleobulo, vedendo definitivamente frustrata ogni speranza di grandezza, impazzisce. Lisarco, che come ricompensa per il suo dramma altro non ha ricevuto da Diego che un mandato d’esilio, impazzisce anche lui. A fare il punto della situazione resta soltanto, unico tra i savi, uno sconcertato Carillo.

CARILLO Cleobulo, Lisauro, e Livio, e Diego
Son tutti fuor di senno.
Diego, che si credea,
Tolto Livio per donna,
Diventarli marito,
Ha perduto la moglie, ed è impazzito.
Livio, che dell’amante
Udì l’estremo caso,
Della speranza ogni pensier smarrito,
Rimasto è senz’amore, ed è impazzito.
Lisauro, che col drama
Credea mercar tesori,
Da Castiglia sbandito,
La cagion non comprende, ed è impazzito.
Cleobulo alla fine,
Che già di farsi grande
Nudrìa stolto prurito,
Sdegnato è con le stelle, ed è impazzito.
Le ultime scene del dramma, già complicato di suo, perdono finalmente ogni pretesa di logica. Ora che tutti i personaggi principali hanno smarrito la ragione, non resta loro altro da fare che aggirarsi sulla scena in preda al delirio, farneticando discorsi senza senso che mettono insieme esclamazioni di rabbia, colti riferimenti mitologici, funesti propositi e sospiri d’amore. E l’epilogo dell’opera, che in mezzo a una scarna scenografia vede Cleobulo, Livio e Lisarco intenti a battibeccare seduti l’uno accanto all’altro su tre sgabelli, ha poco da invidiare a un pezzo da teatro dell’assurdo. Infine, recitata la loro parte, Livio e Lisarco se ne vanno dietro le quinte cantando a squarciagola rispettivamente una «canzon francese» e una «canzon calabrese», mentre all’attore che ha interpretato il vecchio Cleobulo è affidato l’onore di consegnare al pubblico in sala la morale dell’opera:
CLEOBULO Oh quanti stolti! Al fin dell’opra almeno
Chi pazzo diventò sanar si vide;
Ma questi, o popol mio, se tu nol sai,
Quei pazzi son che non guariscon mai.
Ognun n’ha un ramo[6],
Credetelo a me.
Ma il poeta, l’amante e l’astrologo
Un che in pazzia li superi
Trovar non ponno, affé.
Ognun n’ha un ramo,
Credetelo a me.
Sipario.
Sull’accoglienza riservata dagli spettatori al Cleobulo del Neri, purtroppo, poco o nulla sappiamo. Certo è che di qualche fortuna dovette pur godere se nel 1694, undici anni dopo la prima rappresentazione, fu improvvisamente riesumato al Teatro “del publico” di Bologna: nella lettera di dedica del nuovo libretto a stampa, gli accademici che si erano fatti promotori dell’iniziativa deploravano l’ingiusta sorte del dramma «che fra l’ombra d’un accidentale silenzio restò sinora sepolto»[7]. La musica dell’opera, composta dal richiestissimo violoncellista Domenico Gabrielli, è al momento da considerarsi perduta. Non intendo qui fare della sterile polemica letteraria, invocando giustizia postuma per il glorioso e dimenticato nome di Giovanni Battista Neri. Consiglio solo a chi volesse riscoprire una pagina oscura della storia del teatro italiano – forse non importante, ma sicuramente molto divertente – di non perdere tempo a cercare altrove: bussando alla giusta porta, troverà qui un astrologo pronto a soddisfare ogni sua curiosità. Gli si rivolga con piena fiducia, giacché, come la sua scarsissima modestia avrà certo avuto modo di far capire a tutti,
D’ogni interprete d’oracoli,
D’ogni aruspice fatidico,
Affé,
Non v’è
Di me
Il più veridico.
di Federico Flamineo Franchin
Note
[1] La biografia del Neri, insieme a un incompleto catalogo delle sue opere, è in Giovanni Fantuzzi, Notizie degli scrittori bolognesi, Stamperia di San Tommaso d’Aquino, Bologna 1788 – t. VI, p. 157.
[2] L’attribuzione del Celindo al Neri è suggerita da un celebre repertorio di rappresentazioni teatrali, la Drammaturgia di Lione Allacci accresciuta e continuata fino all’anno MDCCLV, stampato a Venezia nel 1755. Benché l’opera non sia sempre precisa nelle sue indicazioni autoriali, in questo caso ritengo che alcune specifiche marche di stile possano avvicinare il libretto alle opere più mature del Neri. Non è questo il luogo per discutere più a lungo di questa mia convinzione, con la quale sarò tuttavia felicissimo di annoiare chiunque avrà voglia di pagarmi una birra.
[3] Degli scritti di Giovanni Battista Neri non esistono edizioni moderne. Tutte le citazioni che seguono sono tratte dal libretto a stampa originale del Cleobulo, che ho consultato nella versione digitalizzata messa a disposizione dal Museo della musica di Bologna, reperibile a questo link. Nel trascrivere il testo, ho occasionalmente modificato la grafia di alcune parole per renderla più conforme all’uso corrente.
[4] Come giustamente sottolineato da Livio nella sua risposta, si tratta di un lungo e barocchissimo giro di parole per descrivere il sorgere del sole. Benché il Neri si diverta a mettere in burla con una certa frequenza questa maniera di verseggiare, egli stesso non andava del tutto immune da simili preziosismi.
[5] Tra queste, che non riferisco nel dettaglio per evitare che i lettori vengano a cercarmi sotto casa, troviamo l’invenzione del parto gemellare che avrebbe dato alla luce due bambini quasi identici di nome Livio e Livia, il fatto che Livio sia sempre vissuto lontano da casa e non sappia nemmeno di avere una sorella, e un’accusa di omicidio addossata al povero Lisarco, che in un duello si sarebbe reso colpevole dell’uccisione del ragazzo.
[6] S’intende, “di follia”. L’immagine della mente umana paragonata a un albero, la cui complessiva armonia è guastata da certi rami malati e storti, è presente nella letteratura italiana sin dal Rinascimento.
[7] Anche il libretto di questa nuova versione è reperibile online.
Leggi tutti i nostri articoli di teatro




