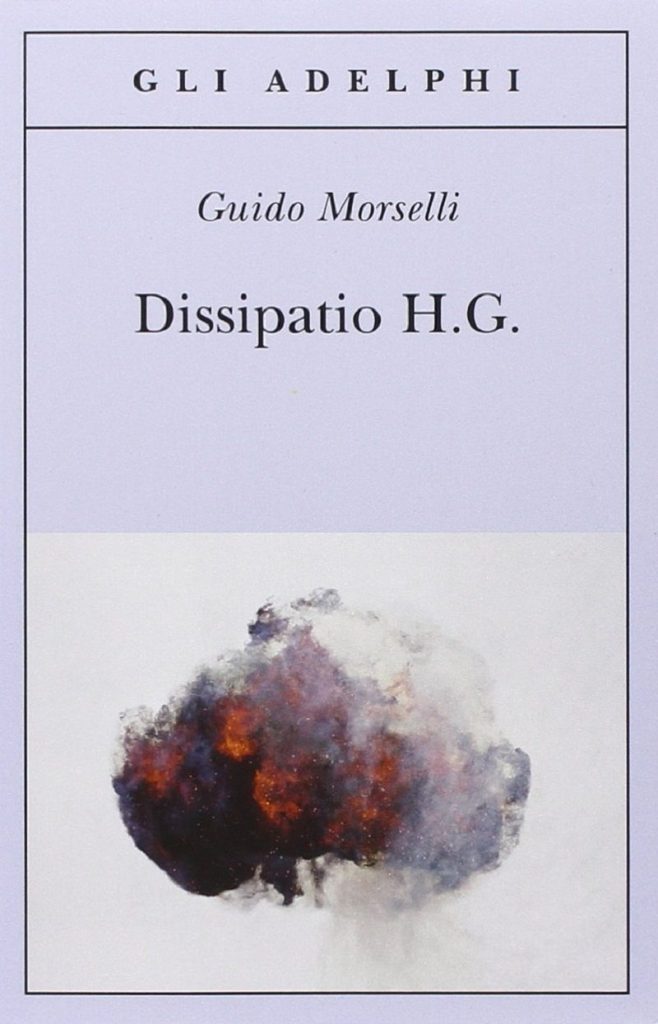Guido Morselli e la sua Dissipatio H.G.
Guido Morselli (Bologna 1912 – Varese 1973) era così abituato ai rifiuti editoriali che, in certi momenti, critica, diffidenza e rifiuto finirono per entrare come corpi, vestiti di abiti più o meno metaletterari, nelle sue opere di finzione. Interpretando in modo originale (ma anche divertentemente naïf) l’invito di Vittorio Sereni, allora direttore letterario di Mondadori, a modificare, in vista di una possibile pubblicazione, il manoscritto di Contro-passato prossimo, lo scrittore inserì un Intermezzo critico in cui L’Editore esemplato così si pronuncia: «Questo vistoso Apocrifo della storia contemporanea, che lei ci sottopone, così carico di tesi da provare, e scarso di appeal, sotto ogni aspetto, le pare proprio che possa andare sotto il nome di Romanzo?».
Basterebbe la lettura anche solo di un paio di opere dello scrittore di Gavirate per rendersi conto che il nostro è un autore che sfugge a ogni tentativo di classificazione. Morselli ha sperimentato con la lingua e con lo stile senza essere avanguardista. Ha messo in questione i generi letterari senza farsi sedurre dalle sirene della Neoavanguardia. È stato in grado di farsi erede di diverse tradizioni saggistico-letterarie senza esserne epigono[1]. La sua singolare parabola creativa – insieme alla sua indole e alle scelte di vita – rende in effetti (parzialmente) comprensibile la difficoltà di farsi pubblicare.
Quando, nell’aprile 1973, termina la stesura definitiva di Dissipatio H.G., Morselli ha alle spalle cinque romanzi non pubblicati[2]. Gli ultimi due, Roma senza Papa e Contro-passato prossimo dimostrano che lo scrittore aveva trovato un terreno fertilmente creativo nel filone utopico e nella narrazione controfattuale. Anche se il protagonista-narratore dichiara di non avere «velleità di scienza; nemmeno […] di fantascienza», la trama di Dissipatio H.G. porta con sé alcune caratteristiche del genere apocalittico-distopico. Il protagonista, «an erudite and neurotically self-aware narrator, a former newspaperman who has left the world behind to write in solitude»[3], all’indomani di un tentato suicidio, si risveglia in un paese completamente svuotato da ogni forma di vita umana. Nessun indizio sembra ricondurre a una forma di distruzione dolosa o violenta: come immaginato dal neoplatonico Giamblico nel IV secolo d.C., gli esseri umani sembrano essersi semplicemente dissipati. La visita all’aeroporto e a Crisopoli, e i disperati tentativi di contatto telefonico “con il mondo” rendono agli occhi dell’uomo sempre più credibile l’ipotesi di essere l’unico essere umano rimasto sulla Terra. Il personaggio-narratore sprofonda in un solipsismo sempre più estremo e, richiamando memorie personali e intellettuali-erudite, si appella a filosofi, teologi, sociologi, scrittori per ragionare su quanto accaduto, interrogandosi anche sul significato del contrappasso a cui l’umanità è andata incontro. Dall’inizio alla fine analizza le proprie reazioni emotive all’Evento mentre si stupisce, gioioso, della riavanzata maestosa della natura. Ritrae poi, e omaggia a suo modo l’umanità appena estinta fra gesti di cinico compiacimento sui resti della civiltà e deliri di paura e di solipsismo: «Ormai la mia storia interiore è la Storia, la storia dell’Umanità. Io sono ormai l’umanità, io sono la Società (U e S maiuscole). Potrei senza enfasi parlare in terza persona: “L’Uomo ha detto così, ha fatto così…”».
Per mettere in scena lo spettacolo di un’umanità appena estinta, Morselli intreccia una rappresentazione a tratti estremamente realistica e suggestiva del mondo improvvisamente svuotato del genere umano, al racconto costruito sull’ossessivo scandaglio delle reazioni che l’Io del narratore oppone all’evento. A modellare il discorso è una riflessione dialogica di stampo filosofico-teologico che mentre da una parte indaga il dolore, il tempo, la solitudine, l’irriducibile soggettività dell’esperienza, dall’altra chiama all’appello, fra gli altri, i neoplatonici, gli autori delle apocalissi apocrife, Borges, Dostoevskij e Agostino d’Ippona intorno ai problemi dell’anima e della fine del mondo.
È evidente che Morselli non ha cambiato opinione su quella che considera la natura del genere romanzo[4]. L’idea che il romanzo non sia altro che una “federazione di generi” mostra anzi qui le sembianze di una poetica. Ne risulta un’interpretazione assolutamente originale e spiazzante del tema “the last man”. Morselli si serve anzi con intelligenza di questo topos letterario e della naturale apertura del genere romanzo per offrire un ritratto impietoso, eppure lucido, di una società appena defunta e dei suoi miti dissolti. È un necrologio davvero singolare quello che l’autore affida alla voce narrante del suo ultimo romanzo.
A questo punto una domanda sorge spontanea: chi sono i destinatari di questo necrologio rovesciato? Cosa sceglie di dire l’ultimo uomo di “loro”? “Che cosa facevano ‘loro’? Si chiede il protagonista non appena l’idea di proseguire l’umanità si affaccia alla sua coscienza. «Be’ è abbastanza semplice: agivano in vista di un’utilità. Inoltre ragionavano sulle cose che si vedevano attorno o che credevano di vedersi dentro. Poi le rappresentavano, parole, segni, suoni. Sarò un riduttivo ma ho idea di non aver tralasciato niente».
Secondo il personaggio «gli uomini hanno avuto il torto (la trovata risale a Albert Camus), se non di cominciare la Storia, di proseguirla». «La loro colpa più recente era l’Imbruttimento del mondo. Si usava aggiungere altre imputazioni: L’Inquinamento, L’Inferocimento (anzi, con eufemismo, la “violenza”). L’Inflazione. (Senza eufemismo: la peste monetaria)». Strettamente collegata alla perdita del timore reverenziale per la natura vasta e incontaminata, «una delle menomazioni vitali di cui soffriva la nostra epoca», la colpa peggiore dell’uomo civilizzato è stata però quella di credersi centro e fine ultimo del mondo.
Del compositore di questo atipico requiem per l’umanità dissolta colpisce quella che si manifesta come un’ambivalenza. Il protagonista appare infatti sempre in bilico fra il gaudio, seppur tetro, per la scomparsa del genere umano e il buio sgomento associato al terrore di essere l’“ultimo uomo”, punta del triangolo in cui confluiscono tutte le generazioni. Verrebbe da chiedersi se un personaggio del genere vada incontro a un cambiamento. È proprio questa domanda a trascinare con sé un altro interrogativo, a mio avviso importante per l’interpretazione del romanzo: è il gaudio alimentato da astio o l’orrore della solitudine a prevalere?
C’è chi ha visto, negli ultimi capitoli, un momento di svolta coscienziale: il protagonista, sperimentati sulla sua pelle il dolore e l’orrore di una solitudine irrimediabile si redimerebbe dal peccato di superbia, pentendosi di non essere uscito per tempo dalla prigione del proprio solipsismo[5].
Pur trattandosi di una lettura tanto interessante quanto moralmente “rassicurante” che si giustifica con l’identificazione in un altro testo dell’autore, Fede e Critica, dei motivi intellettuali e autobiografici utili a condurre un’ermeneutica del discorso morale di Dissipatio H.G., mi sembra che una simile prospettiva rischi non solo di portare a un’interpretazione, a mio avviso, fuorviante del romanzo, ma metta in ombra la sua qualità migliore: un’estrema e costitutiva vocazione nichilista.
È pur vero, infatti, che dopo un saliscendi di maree umorali, il protagonista inizia a denunciare l’insostenibilità angosciosa della condizione in cui si trova. Al culmine dello spaesamento, nell’inquietante soliloquio “Cronaca della paura” sembra quindi profilarsi una sorta di conversione. Lo snodo morale nella parabola esistenziale (e narrativa) del personaggio sarebbe finalmente raggiunto: «Fatemi morire – invoca il narratore, indirizzandosi a nessuno – nel bene o nel male li devo raggiungere. Non ero diverso da loro, mi assomigliavano tutti. Ignoranza e superbia incluse». Eppure, ciò che il protagonista senza nome dichiara in un barlume di umiltà egualitaria e solidale, si accompagna ad altrettanti gesti di smentita. Infatti, mentre lamenta una “frenetica nostalgia”, una “privazione aspra”, un “rimpianto amaro” per quel “bene irrecuperabile” che era la consuetudine con i propri concittadini, l’unico scampato alla generale e improvvisa dissipatio si scaglia contro l’Hôtel Victoria, che dei propri simili porta un’impronta fastidiosa: «Alle 14 e 15 precise accendo il fiammifero giustiziere».
Ma c’è di più. Anche se decidessimo di credere a quelle parole del nostro protagonista – insieme personaggio solipsista e narratore inattendibile – che odorano di redenzione così come ai disperati tentativi di contatto con supposte forme di vita umana residue, come tapparsi le orecchie di fronte al tono cinicamente beffardo con cui sceglie di rappresentare – dall’inizio alla fine del suo monologo – la dissipazione dell’umanità?
Per rispondere agli interrogativi sollevati sopra forse è utile concentrarsi proprio sul tono che l’ultimo uomo sceglie per rappresentare l’apocalisse e quindi sulle caratteristiche linguistico-retoriche del suo monologo.
Un primo indizio di assenza di pietà compartecipe mi sembra sia dato dalla scelta dei denotata per indicare gli esseri umani scomparsi che vengono indicati di volta in volta come “Loro”, “gli scomparsi”, “razza di bipedi”, “formicolanti miliardi di esseri della stessa specie”, “evasi”, “questa gente”, “cari scomparsi”, “cari estinti”. Rimanendo sempre nel campo della denotazione, si nota poi un certo indugio divertito nella scelta con cui di volta in volta si indica la scomparsa degli umani: “l’Evento”, “l’Exitu de Aegypto”, “l’Inspiegabile”, “Esodo”, “Bomba X”, “Operazione pulizia”, “Volatilizzazione”, “Sublimazione”, “assunzione nei cieli”, “dissipazione”.
Anche se la scelta delle alternative linguistiche sembra in alcuni funzionale a uno scandaglio delle implicazioni fisiche e metafisiche dell’evento, il freddo gioco linguistico e retorico che si costruisce intorno alla denotazione dell’avvenimento, fa irrompere, prepotente, la sensazione che la voce narrante stia ironizzando, secondo le sue modalità tonali, su quanto accaduto. Credo poi che altre strategie linguistico-discorsive rivelatrici della carica distruttiva di Dissipatio H.G siano tanto la diffusa e gelida ironia che colpisce i miti della società appena dissolta[6] quanto un singolare gusto per la fredda elucubrazione logico-retorica. Per dare solo due esempi: «L’idea assurda mi si affaccia […] prima erano gli incidenti d’auto che toglievano la vita: in quel momento fu il togliersi la vita che (il suo sottrarsi, svanire) a produrre l’incidente», «Quando ero ragazzo i contadini di quelle parti chiamavano i vagoni della ferrovia “le vacche grigie”. Adesso le vacche grigie pascolano tranquille, i Kilowatt, come gli HP, rientrano nella natura. Bradi».
Cosa dire infine del modo in cui il narratore distrugge il mito della rinascita? L’ipotesi di un’altra umanità può essere avanzata solo se annichilita in partenza dalla forza disgregante di uno humor che difficilmente potrebbe essere più nero: il nostro uomo si immagina a seminare, come un novello Deucalione, compresse di meprobamato nel campo da tennis che ha ospitato le partite di coppa Davis, augurandosi di propiziare una razza più calma e mano rissosa. «Se nasceranno saranno bella gente, come i campioni del tennis, e connaturati al fair-play, come quelli. Le spargerò con parsimonia. È una razza che ha l’abitudine di moltiplicarsi esponenzialmente. Non si sa mai».
Mi sembra chiaro che la voce narrante di Dissipatio H.G., non faccia in alcun modo ammenda del proprio solipsismo, della sua vita passata a evitare l’“altro”. Credo anzi che questo discorso costruito fin dalle fondamenta su un sarcasmo aggressivo e sulla beffa acre, trovi la sua forza proprio nell’assenza di ravvedimenti coscienziali. Forse è proprio la totale mancanza di fede, rimpianto e speranza il valore aggiunto del racconto di Morselli.
Mi sembra inoltre che le strategie linguistico-retoriche adottate riescano nell’impresa di dare forma a una rappresentazione dell’apocalisse originalmente anti-epica, miracolosamente anti-tragica e priva di drammaticità compartecipe. È anzi proprio questo contesto a far risplendere con più intensità il forte potere immaginifico della rappresentazione[7]. Lo scrittore di Gavirate è stato infatti capace non solo di trasformare le ipotesi metafisiche sulla dissoluzione in immagini allo stesso tempo grandiose e ridicolizzanti[8] ma, attraverso la sua speculazione immaginifica è riuscito a dotare la riflessione teologico-filosofica di senso tattile.
Sono quindi l’atteggiamento e il tono della voce narrante a spazzare via ogni dubbio sul quella che mi sembra essere l’anima e la grandezza dell’ultimo romanzo di Morselli: un’ineliminabile e coraggiosa vocazione distruttiva, estrema, nichilista. L’astio del fobantropo solipsista è lì, nella lingua e risuona cupo e sprezzante nelle orecchie del lettore.
L’“irritazione radicale”[9] non è solo quella di un intellettuale isolato verso «questo nostro secolo che discriminava, non faceva altro che discriminare secondo i suoi codici rigorosi e innumerevoli». L’irritazione radicale di Dissipatio H.G. è un meraviglioso canto funebre di fredda e rassegnata constatazione sui resti di una società fallita.
PS. Mentre ultimo l’articolo scopro che Morselli è stato nominato scrittore dell’anno dal New Yorker e che la traduzione di Dissipatio H.G. ha appena visto la pubblicazione nella collana Classics del New York Review of Books & Inc.
Note
[1] Oltre ai modelli letterario di Proust e Svevo, e di Mary Shelley, Shiel, Michelle Verne per i romanzi utopici, gran parte della critica è concorde nel considerare Morselli un erede del Leopardi delle Operette morali così come dei philosophes francesi del Settecento.
[2] In ordine di composizione: Incontro con il comunista, Un dramma borghese, Il comunista, Roma senza papa, Contro-passato prossimo. Gli unici testi che lo scrittore ha visto pubblicati nel corso della sua vita sono due saggi di carattere letterario: Proust o del sentimento, edito da Garzanti nel 1943, e Realismo e fantasia, edito da Bocca nel 1947. Entrambi i volumi videro la luce solo grazie al contributo economico del padre di Morselli.
[3] https://www.newyorker.com/magazine/2021/01/04/the-italian-novelist-who-envisioned-a-world-without-humanity
[4] “I romanzologi o notomizzatori nostrani del romanzo partono probabilmente da un’implicita premessa che non potrebbe essere più ligia alla tradizione retorica: che il romanzo sia “un” genere letterario. Quand’è invece, e lo era già in prossimità delle origini, una federazione di generi letterari, a mala pena tenuti insieme da quella vaga e sfuggente caratteristica che è il loro essere tutti più o meno in prosa e tutti più o meno racconti” (G. Morselli, Diario, scelta a cura di G.Pontiggia e note di V.Fortichiari, Milano, Adelphi, 1988).
[5] Maria Panetta, Da Fede e critica a Dissipatio H.G.: Morselli, il solipsismo e il peccato della superbia, in “Biblioteca di Rivista di Studi Italiani”.
[6] «Chi se ne va da questo mondo ‘passa a miglior vita’, dicevano. E il cartellone invitava appunto a andare ‘dove la vita è migliore’. La morte-premio, come emigrazione turistica collettiva, si può concepire, in un secolo com’era il nostro, vastamente dedito all’educativo esercizio del viaggiare (…) Però si pone il problema logistico. La ‘ricettività’ ha la sua importanza anche per i puri spiriti. Né le Bahamas né tutte le Antille messe insieme potrebbero ospitare una così smisurata collettività. Il paradiso deve pure offrire un minimo di comfort». (p. 77)
[7] Le vesti che in quell’attimo coprivano i corpi, hanno condiviso la sorte dei corpi che coprivano. Invasione di nylon, rayon, lilion e altre fibre tessili negli “intermundia”.
[8] «Adesso direttori, editori, scrittori, colleghi, ex-colleghi e pseudo amici stanno di là. Calcano i glabri pendii del monte Armageddon. In attesa dell’estrema sentenza, scavano occhiuti con le unghie la cenere, a coprirne le telex e le macchine da scrivere a cui sono, giustamente, incatenati. Angeli vigilano dall’alto del monte onde non fuggano».
[9] Riprendo l’espressione da Bruno Pischedda, La grande sera del mondo. Romanzi apocalittici nell’Italia del benessere, Torino, Aragno, 2004.