Le violenze della polizia nel carcere di Santa Maria Capua Vetere pongono all’ordine del giorno un’analisi delle forze dell’ordine. In particolare, viene da chiedersi: perché la polizia tende, così spesso, ad agire in maniera sproporzionalmente violenta? E perché questo avviene tanto come risposta alle manifestazioni politiche, quanto durante normali operazioni di “ordine pubblico”? In quest’articolo proveremo a dare una risposta. Non sarà certamente l’ultima parola su questa questione, né pretendiamo che lo sia. Piuttosto ci piacerebbe che queste pagine siano di spunto per ulteriori e più approfondite analisi, capaci di guardare al processo di formazione delle polizie in tutto il mondo e di analizzare, caso per caso, tutte le situazioni in cui le forze dell’ordine mostrano comportamenti ingiustificatamente aggressivi.
Che il senso comune non sia garanzia di verità è ormai cosa nota. Gli scienziati lo sanno bene. Copernico, Galileo, Newton, Einstein… Tutti loro hanno messo in discussione e confutato le risposte considerate dalla maggioranza vere perché “ovvie”.
Tuttavia, chi si impegna nel portare avanti un’indagine scientifica della realtà non può limitarsi a confutarlo: è necessario comprenderlo, analizzarlo ed evidenziarne le contraddizioni intrinseche. Per questo, chi come noi si propone di indagare l’essenza ideologica e materiale delle forze dell’ordine deve innanzitutto soffermarsi sulla loro rappresentazione nell’immaginario sociale.
Per il senso comune, il compito delle forze dell’ordine è quello di far rispettare la legge e, di conseguenza, di difendere i cittadini. E che cosa ci può essere di più ovvio? Chi può, infatti, meglio di coloro che giurano di servire lo Stato, garantire alla collettività la sicurezza data dall’obbedienza alla legge?
Senonché, riflettendoci più attentamente, si nota che questa ovvietà non è tanto ovvia e che forse c’è bisogno di un surplus di riflessione. È quello che cercheremo di fare.
Ora, a prima vista, le forze dell’ordine hanno una posizione intermedia tra società civile e Stato. Le decisioni prese da quest’ultimo (le leggi) possono infatti venir applicate solo grazie a una forza organizzata (i corpi di polizia), che obbliga i membri della società (i cittadini) al rispetto di queste scelte. I cittadini, d’altra parte, possono appellarsi alle forze dell’ordine ogni volta che subiscono un torto.
Ma il loro essere in una posizione intermedia è solo apparenza. Innanzitutto, perché il rapporto tra Stato e società non è accidentale, non “capita per caso” e non ha bisogno di “elementi terzi” (come la polizia) per entrare in relazione. Stato e società, al contrario, sono strettamente connessi, al punto che si può dire che lo Stato è l’istituzionalizzazione dei rapporti sociali vigenti. In secondo luogo, e soprattutto perché, in quanto corpi dello Stato, le forze dell’ordine sono essenzialmente legate ai suoi destini (il motto dei Carabinieri è non per caso «Fedele nei secoli»). Le loro azioni rispondono a chi gestisce il potere statuale (e quindi sociale) e hanno il fine principale di garantirne l’esistenza. Il nome di «forze dell’ordine» è, da questo punto di vista, più che mai appropriato.
E tuttavia le forze dell’ordine non sono lo Stato. Qualora lo diventassero, si parlerebbe di dittatura militare o di Stato di polizia. Piuttosto, ne sono una parte, la quale entra in relazione con le altre e, in particolare, con il potere politico: con quell’istituzione, cioè, che ha lo specifico compito di elaborare le leggi.
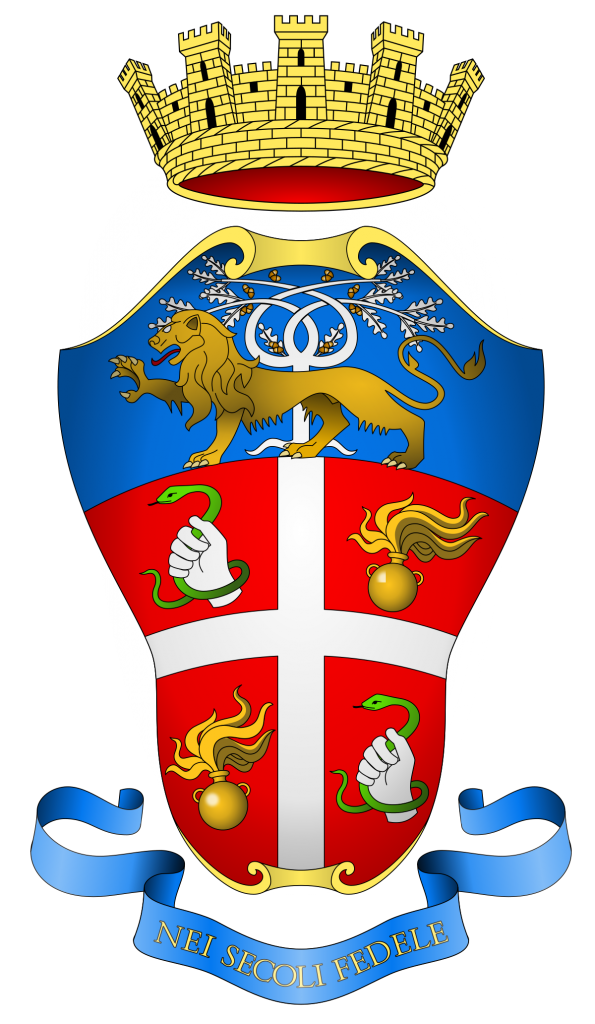
Ma non si tratta di una relazione immediata, semplice. La stessa espressione «corpi», riferita ai «corpi di polizia» lo indica. Il «corpo», infatti, è propriamente un organismo, ciò che è «capace di vivere autonomamente, cioè di conservare ed eventualmente reintegrare la propria forma, e di riprodursi». In che modo un «corpo», cioè qualcosa che può addirittura «vivere autonomamente» essere parte di un organismo come lo Stato?
Sembra evidente che con questo termine, tanto peculiare, si voglia indicare una caratteristica specifica, che si voglia sottolineare che le forze dell’ordine non sono uguali ad ogni altro elemento dell’apparato amministrativo. La Polizia insomma non è l’Ufficio catasti. E non solo per l’ovvia ragione che si occupa di tutt’altro, ma soprattutto perché il loro “esser parte dello Stato” è un prendere parte come qualcosa di diverso dallo Stato stesso. Perché vi è in loro un principio che li rende diversi, speciali, in grado di sussistere, appunto!, autonomamente da tutto il resto.
La Polizia, dunque, non è l’Ufficio catasti innanzitutto perché gode di una particolare autonomia. Assomiglia in questo alle corporazioni medievali (“corporazione” non a caso viene da corporatio, «prender corpo»): un gruppo sociale con statuti speciali, privilegi speciali, in grado di auto-organizzarsi e di riprodursi. E infatti chi appartiene alle forze dell’ordine ha un ruolo, dei diritti e dei doveri diversi dal comune cittadino. È parte di un gruppo di suoi simili con cui solidarizza e con cui “fa gruppo”. Rende conto innanzitutto ai suoi superiori, cioè ad altri individui che sono parte del corpo a cui appartiene.

Parlare di autonomia non significa tuttavia parlare di indipendenza. Sarebbe errato affermare che siamo in presenza di un completo scollamento tra i settori predisposti alla repressione dei comportamenti illeciti e lo Stato tout court. E da parte di chi gestisce il potere politico sembra esserci almeno la latente consapevolezza della corporativizzazione delle forze dell’ordine. In questo senso, può essere letto l’ostruzionismo ad ogni legge che limita l’arbitrio della polizia, come ad esempio i numeri identificativi o una seria legge sulla tortura. Operare con decisione, introducendo queste norme, significherebbe per invertire il processo di autonomizzazione in atto e perciò contrapporsi agli unici in grado di garantire un controllo effettivo sulla società. Una conseguenza potenzialmente pericolosa, visto che il potere si fonda sul sempre precario equilibrio di consenso e coercizione e oggi la cosiddetta “casta politica” sembra in sempre maggiore crisi di legittimità.
Ma, come si suol dire, tutto ha un prezzo. In cambio della garanzia di intangibilità e di relativa discrezionalità nell’operare, chi gestisce il potere politico chiede alle forze dell’ordine soprattutto due cose: l’intervento tempestivo ed efficace contro ogni fenomeno sociale “deviante” e la capacità di assumersi responsabilità che non le dovrebbero concernere. È il caso delle limitazioni, antidemocratiche e dalle connotazioni poliziesche, alle libertà personali.
Scelte politiche (e in quanto tali necessariamente di parte), vengono spacciate come scelte tecniche, dettate dalla necessità di adeguarsi a richieste insindacabili di un apparato dello Stato dai compiti in teoria puramente esecutivi. Sono un esempio di questa tendenza le dichiarazioni di quest’estate del sindaco di Bologna, Virginio Merola, in occasione degli sgomberi dei centri sociali Làbas e Crash. Non viene rivendicata politicamente una gestione politica della città e dei suoi spazi (per inciso, una gestione iniziata con Cofferati e improntata alla chiusura dei luoghi di aggregazione giovanile non improntati ad una logica commerciale) ma viene demandata ogni responsabilità alla magistratura e, come se si avesse a che fare con dei novelli Ponzio Pilato, viene affermata l’impossibilità di «interferire» da parte del potere politico.
Il che, se fosse vero, sarebbe aberrante! Ma come? I rappresentanti dei cittadini, del «popolo sovrano» come recita la Costituzione, non possono aprir bocca sulle scelte fatte da un apparato dello Stato? Di solito, quando questo accade, lo si chiama golpe. Ma poiché di colpi di Stato non ce ne sono stati, come è possibile questo scollamento? È evidente che è frutto di una precisa scelta politica. La scelta di lavarsi le mani delle proprie responsabilità.
Ma torniamo al processo di corporativizzazione. Anche nelle forze dell’ordine c’è la consapevolezza di fare “mondo a sé”, ma, a causa della loro struttura, non si può pensare che la concezione del rapporto tra corpi di polizia e Stato di un dirigente sia uguale a quella di un sottoposto.
Il primo ha infatti il compito di gestire l’apparato poliziesco (nel suo complesso o in alcune sue parti, a seconda del grado e della posizione che occupa nell’organigramma). Per questa ragione ha perciò il delicato compito di contrattare con il potere politico, di volta in volta, la disponibilità delle forze dell’ordine a mantenere una certa linea nella gestione dell’ordine pubblico in cambio di alcuni diritti o, meglio, privilegi.
Il subordinato invece vive il suo rapporto con le istituzioni in maniera completamente differente. In quanto parte di un gruppo stabile (il plotone, la caserma, ecc.), il cui accesso è strettamente regolamentato e frutto di una progressiva accettazione delle norme di vita interne (la fase dell’addestramento è fondamentale in ogni microcomunità), il singolo finisce per identificarsi con il gruppo stesso, per condividerne i valori e le esigenze. Egli può anche pensarsi genericamente come «fedele servitore dello Stato», ma inevitabilmente, nella sua prassi quotidiana risentirà, dell’educazione impartitagli. Un’educazione che si sostanzia nella volontà di plasmare e riconfigurare personalità e visione del mondo delle reclute e che il filosofo Michel Foucault definiva «pedagogia del corpo».
L’esito è il “tipo del soldato”: vero e proprio modello antropologico per il quale il singolo si sente immancabilmente subordinato al gruppo. E allora rispetto della gerarchia, obbedienza verso i superiori, senso di appartenenza che arriva fino all’identificazione assoluta, solidarietà acritica nei confronti dei sodali, deresponsabilizzazione delle azioni (l’aver «solo obbedito agli ordini») sono tutti elementi che concorrono a definire l’essenza di questa particolare mentalità. Come notano Charlie Barnao e Pietro Saitta, autori di un lavoro sulla Folgore intitolato Autoritarismo e costruzione di personalità fasciste nelle forze armate: un’autoetnografia questa forma mentis non è solo un incentivo nei confronti di atteggiamenti “camerateschi” più o meno violenti (il nonnismo), ma fornisce la base della diffusione di ideologie intrinsecamente violente e antidemocratiche (addirittura fasciste) tra le forze armate e i corpi di polizia.
Non stupisce allora che i paracadutisti della Folgore cantino canzoni di questo tipo, che a Bolzaneto nel 2001 facessero urlare «1, 2, 3 viva Pinochet!» oppure «Viva il Duce!», oppure che interi reparti, sempre a Genova durante il G8, siano stati coinvolti in atti di tortura riconosciuti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
L’“individuo poliziotto”, nell’entrare a far parte organicamente del corpo di polizia, rinuncia necessariamente alla propria personalità, finendo per acquisire la cultura e i fini del corpo a cui appartiene.
E come una mano, staccata dal braccio, diventa un semplice pezzo di carne, così l’“individuo poliziotto”, staccato dal gruppo, si trova ad essere uno “sradicato”, una sorta di “apolide”. È questa la ragione per cui tenderà a schierarsi sempre con il corpo di appartenenza, anche a costo di tacere su gesti criminali dei suoi compagni o di parteciparvi in prima persona (è il caso, per esempio, della mobilitazione avvenuta in occasione del tentato, e poi fallito, golpe del 1970 diretto da Junio Valerio Borghese, che aveva coinvolto le forze armate, i carabinieri, gruppi neofascisti e Cosa Nostra)[1].
Ma se la fedeltà al corpo viene prima della fedeltà allo Stato, se l’apparato diventa sempre più una corporazione, qual è allora la reale funzione delle forze dell’ordine?
Sembra tautologico dirlo ma non lo è: innanzitutto, mantenere l’ordine a tutti i costi. L’ordine sociale, garanzia dell’ordine statuale, garanzia dell’ordine nel gruppo di cui si è parte. L’intervento, allora, non sarà necessariamente finalizzato alla repressione di un reato. Ogni azione, compiuta da un singolo o, ancor di più da un gruppo organizzato, che mette a repentaglio lo status quo diventa un pericolo mortale contro cui combattere. Ecco la ragione delle continue azioni ingiustificatamente violente contro cortei, manifestazioni, iniziative politiche o addirittura normali comportamenti di vita quotidiana, come bersi una birra all’aperto. In Italia, ma non solo: in Francia, in Ucraina, negli USA, in Spagna… Gli esempi si potrebbero moltiplicare. Ed ecco perché il capo della Polizia, Franco Gabrielli, dice una cosa falsa quando afferma che la polizia è “sana”.
Perché una “malattia” c’è. E riguarda la struttura delle forze dell’ordine, la cultura diffusa al loro interno, l’educazione che viene impartita, ma soprattutto, la loro ragione d’essere.
Note
[1] Per chi fosse interessato suggeriamo la lettura di questo libro.








