Quanto orrore può generare un pozzo che diventa una prigione?
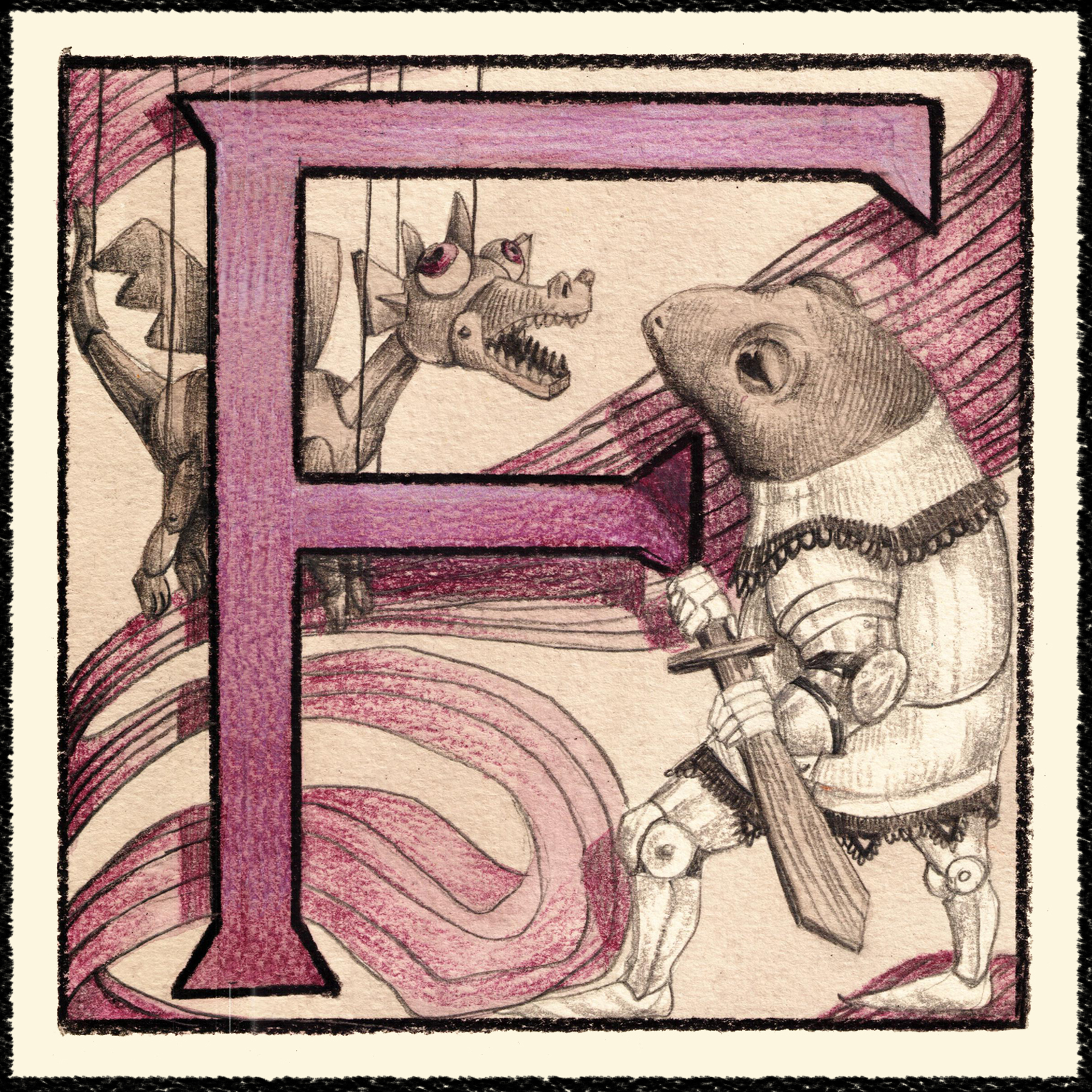
a così l’incipit di uno dei più celebri racconti della storia della letteratura, Il pozzo e il pendolo di Edgar Allan Poe, pubblicato originariamente a Philadelphia, nell’antologia The Gift: a Christmas and New Year’s Present for 1843:
Ero stomacato – stomacato a morte di quella lenta agonia…[1]
La traduzione, Maria Gallone per la BUR, si discosta dall’originale solo nella “lenta agonia”, mutata da “long agony”. In italiano l’agonia è paradigmaticamente lenta, un rafforzativo divenuto automatico.
L’incipit è costruito intorno a tre termini-chiave che anticipano il cuore concettuale e la strategia tecnica della costruzione letteraria: “agonia”, “morte” e “stomacato”. L’agonia di cui riferisce il protagonista, che rimarrà senza nome, è dovuta alla snervante attesa della sentenza in procinto di colpirlo: una sentenza capitale. Soltanto un piccolo assaggio dell’agonia terrificante che lo aspetta nelle segrete della prigione di Toledo, inferno in terra della Santa Inquisizione. La morte, terrore primario di ogni essere umano e ingrediente principe di ogni racconto dell’orrore che si rispetti, sarà la naturale conclusione delle torture di prassi. Se da un lato la morte è il male supremo, l’annientamento che l’individuo si sforza in tutti i modi di scampare, dall’altro può divenire l’unica via d’uscita, l’agognata liberazione dalle sofferenze patite in questo mondo. Un paradosso sul quale i filosofi dibattono dalla notte dei tempi, da Zoroastro almeno, e che in Poe sfocia nella poetica del grottesco. L’idea è che il terrore e la meraviglia suscitate dalle esperienze spaventose, se descritte con vividezza e dettagliamento pittorico, possano elevare lo spirito a uno stato di magnificenza. Il terzo termine-chiave è “stomacato”, ripetuto immediatamente e rafforzato in “stomacato a morte”. L’originale inglese “sick” perde forza nella traduzione. “Sickness” designa un malessere fisico e spirituale, uno svuotamento delle energie corporee e mentali, un’abulia vicina alla disperazione che qui porta alla caduta nelle tenebre dell’incoscienza. Questo “stomacato” è il primo di una lunga serie di aggettivi atti a descrivere le sensazioni dolorose o spaventose che si susseguono nel corso del racconto, caratterizzandolo come “racconto di sensazioni”. Proprio su questo aspetto si è concentrata la critica, in positivo e in negativo. William Butler Yeats, massimo poeta irlandese e premio Nobel nel 1923, non apprezzava in generale l’opera di Poe, che riteneva “volgare”. In riferimento a Il pozzo e il pendolo scrisse: «Non mi pare che abbia alcun tipo di durevole valore letterario. Analizzatelo e scoprirete il continuo tentativo di suscitare terrore tramite l’evocazione di sensazioni fisiche dozzinali»[2]. Eppure, questo “appello ai nervi”, un elemento di realismo che favorisce l’immedesimazione del lettore con il protagonista, ha contribuito alla straordinaria fortuna del racconto presso il pubblico. Al contrario di altri racconti di Poe, che risentono di una poetica neoromantica e simbolista un po’ démodé, Il pozzo e il pendolo mantiene inalterata la sua forza drammatica; l’attenzione al realismo delle percezioni conferisce alla narrazione un carattere di universalità che ne previene l’invecchiamento.

Il racconto si rivela sin dall’incipit come “dramatic monologue”, ovvero una narrazione drammatica in forma monologica attraverso cui si dipana la storia ed emerge la psicologia del protagonista. Questa forma tradizionale della letteratura anglosassone, portata al massimo splendore in epoca vittoriana da Robert Browning (My Last Duchess) e divenuta in seguito un classico delle folk ballads, ha origine nel The Wanderer, poema in metro allitterativo contenuto nel Codice di Exeter, un manoscritto del X secolo.
Il pozzo e il pendolo si compone di quattro parti o “stanze”, almeno tre delle quali sono divenute solidi topoi letterari (cosa più unica che rara), separate da nette cesure o “cadute”. Lo stratagemma usato da Poe per spezzare la continuità narrativa è il mancamento. Per tre volte il protagonista sviene o si addormenta, permettendo all’autore di farlo rinvenire in una nuova e più terrificante condizione. L’atmosfera e la condizione psicologica del narratore vengono dipinte in un raffinato gioco di luce e ombra, una progressiva caduta nelle tenebre della paura seguita da un’ambigua risalita verso salvezza e illuminazione. Il potere dell’oscurità può innalzare sino al limite del sublime il terrore dell’animo umano. Nella prima parte il narratore viene presentato in attesa della sentenza, “stomacato a morte”. L’accusa è ignota, l’effettiva colpevolezza irrilevante. L’attenzione del protagonista si concentra sulle «labbra dei giudici ammantati di nero. Esse mi apparivano bianche, più bianche del foglio su cui traccio queste parole». Questa frase, posta all’inizio del racconto, ci suggerisce anche che la morte, «l’ineffabile dolcezza del riposo nella tomba», non sarà la conclusione della vicenda. Pronunciata la sentenza, sopraggiunge lo svenimento. Il risveglio è nell’oscurità, tanto che il protagonista teme di esser stato sepolto vivo. Inizia quindi a esplorare lo spazio a tentoni: una cella circolare. Dopo averne percorso il perimetro per stabilirne le dimensioni, il protagonista tenta di attraversarla diametralmente ma inciampa in un brandello della veste strappata, cade e si ritrova a sporgersi con il volto nel vuoto. Celato nell’oscurità, nel centro della cella, si apre il pozzo, la prima morte alla quale i monaci lo hanno destinato. Scampato il pericolo, ed esausto per la debolezza, si addormenta. Quando riprende i sensi è legato a un tavolo, supino. Su di lui incombe la seconda morte: un pesante lama fissata a una corda, che oscilla come un pendolo e inesorabilmente cala, centimetro dopo centimetro. Una sottile fessura apertasi in una parete attenua l’oscurità permettendogli di vedere il supplizio cui è destinato. Il meccanismo scende con lentezza esasperante, trascinando il protagonista a un livello di terrore che sfiora il delirio. Può muovere solo la mano sinistra, accanto alla quale i carcerieri hanno lasciato del cibo. Richiamati dall’odore, grossi topi emergono dal pozzo e si aggirano per la cella. Quando la lama è ormai giunta a sfiorargli le carni, il nostro ha l’intuizione che lo salva: sfrega i rimasugli di cibo sulle cinghie attirando così i topi, che rosicchiano i legacci e lo liberano. Come fosse infuriata per il fallimento dell’esecuzione, la cella prende a mutar forma, le pareti metalliche diventano incandescenti, l’ambiente si surriscalda e una luce infernale invade la segreta. Per scampare il nuovo pericolo il protagonista si rifugia sul bordo del pozzo, ma le pareti arroventate si fanno sempre più vicine e…
All’improvviso il meccanismo si blocca, giungono urla e stridore di combattimenti, finalmente «un braccio si tese ad afferrare il mio mentre cadevo privo di sensi entro l’abisso». L’esercito francese ha conquistato Toledo, l’Inquisizione è caduta nelle mani dei suoi nemici.
Contrariamente ad altri racconti di Poe, in cui elementi soprannaturali intervengono a generare terrore, Il pozzo e il pendolo è costruito sul realismo delle sensazioni e sulla crudeltà umana, razionale al limite del cervellotico. Esattamente come razionale, addirittura analitica è l’attitudine del protagonista. Mantenendo la lucidità anche in situazioni di estrema sofferenza psichica, pianificate per condurlo allo sconforto e alla follia, il nostro riesce a rimandare la morte, a guadagnare quel poco di tempo che lo salverà. La mente umana, posta sotto il forte stress dovuto a un’esperienza terrificante, è costretta ad analizzare la propria condizione al di là della visione comune, avviandosi così sulla via dello stato emotivo trascendente. Questo elemento razionale avvicina il protagonista de Il pozzo e il pendolo a un altro eroe di Poe: l’investigatore parigino Auguste Dupin, primo della stirpe dei moderni detectives.
Il pozzo e il pendolo è il capolavoro che Edgar Allan Poe lascia in dote alla letteratura mondiale, al pari de Il corvo e Le avventure di Gordon Pym, opere che lasciano un segno indelebile nel gusto del pubblico e inaugurano una tradizione “nera” nella letteratura americana, e anche nel cinema.
di T.D. D’Orfeo
Leggi tutti gli articoli del numero 21




