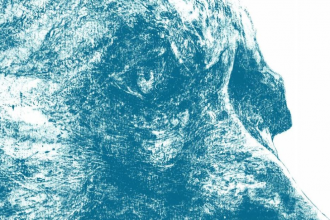di Ilaria Iannuzzi
///
Il percorso dell’arte contemporanea – dalle Avanguardie storiche a oggi – può essere visto come una battuta in ritirata: prima del disegno, poi della figuratività, poi persino del colore e dell’oggetto artistico stesso, finendo per approdare a quel grado di rinuncia estrema che oggi è sempre più pervasivo e che spesso ha il sapore del nichilismo.
La via creativa percorsa da Ōki Izumi è in parte la regola, in parte l’eccezione. Da un lato, la scelta di lavorare con un materiale trasparente come il vetro costituisce un implicito orientamento verso l’astrazione, che si è spogliata innanzitutto del colore, ma anche di una precisa definizione delle forme. Dall’altro, nonostante la freddezza e la durezza del suo materiale prediletto, le sue sculture non pervengono affatto al gelo di un’arte arroccatasi sul puro formalismo, che, pur di lasciarsi alle spalle qualche altro retaggio della tradizione, si ritira anche dal gioco di suscitare un vero coinvolgimento. Ōki, invece, al gioco ci sta: le sue opere vogliono essere emozionali, immaginative e, soprattutto, belle.
Formatasi a Tokyo studiando letteratura giapponese antica e archeologia, Ōki avrebbe intrapreso la carriera accademica se una serie di sfortunati ostacoli e insieme di felici coincidenze non l’avessero condotta sulla strada dell’arte. Inizia con un corso di pittura tradizionale giapponese, ma il suo maestro la indirizza verso sfide più moderne e verso la scultura. È in questo momento che comincia a sperimentare con il vetro, dapprima dipingendovi sopra, poi abbandonando progressivamente il colore e la figura. Dopo aver vinto una borsa di studio a Milano si trasferisce in quell’Europa che la affascinava da quando era bambina, e qui frequenta l’Accademia di Brera. Passa quattro anni a imparare a gestire i materiali scultorei tradizionali, ma appena termina gli studi ritorna al suo primo amore: il vetro.
Il vetro che utilizza è quello delle finestre, dal colore verdazzurro che fa pensare alla leggerezza dell’aria e dell’acqua – due elementi centrali nella cultura giapponese che sono una costante nel lavoro e nell’ispirazione di Ōki –, ma che in realtà è estremamente duro e pesante (il suo peso specifico è pari a quello del marmo). La sua durezza rende il taglio tanto difficile che l’artista, per realizzarlo manualmente, si trova a dover utilizzare sempre forme quadrate e rettangolari, mai curve. Questa semplificazione geometrica imposta (o suggerita) dai limiti tecnici (o possibilità) del materiale trova una perfetta sintonia con l’attitudine all’ordine e il rigore propria della sua “nipponicità” (quando le propongo questo termine le piace tanto che corre subito a scriverselo!). Nonostante l’utilizzo di forme squadrate, Ōki riesce comunque a dare sinuosità alle sue sculture attraverso il taglio obliquo dei pezzi e la progressiva rotazione delle lastre sovrapposte le une alle altre. La maggior parte delle sue composizioni, infatti, sono costruite attraverso “stratificazioni” di lastre, che danno forma a vasi, architetture immaginarie di fortezze e labirinti, oggetti surreali come una misteriosa nave cosmica. Solo più recentemente ha cominciato a sperimentare anche l’elevazione dei vari pezzi di vetro in verticale, per formare composizioni spiraliche e profili di edifici a metà strada tra rovine di antiche cattedrali e avveniristici grattacieli.
Sarebbe impossibile dare un’interpretazione univoca al significato di queste sculture ambigue e leggermente oniriche, che mutano col mutare della luce solare, che – come ha scritto Bruno Munari – riflettono e fanno riflettere.[1] Ma è proprio questo ciò che interessa a Ōki Izumi: alludere, attraverso la forma, a una dimensione che vada oltre la forma stessa, offrendo così all’immaginazione dello spettatore lo spunto per tirare fuori quel qualcosa in più da dentro di sé.
Note
[1] Qui la recensione completa di Bruno Munari a Ōki Izumi.



![DSC05049 [ anna lav ]](http://www.latigredicarta.it/wp-content/uploads/2016/07/DSC05049-anna-lav--1024x683.jpg)