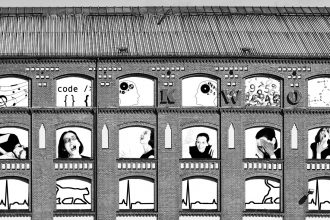di John De Martino
///

Progresso graduale ma inesorabile di uno dei mostri sacri della storia del jazz. La forza di Herbie Hancock fu forse la grande umiltà di voler imparare anche dopo quasi settant’anni di musica, senza mai considerarsi “arrivato”. Il compimento è sempre la meta da raggiungere.
C’è ormai una comprovata ricorrenza nei temi che l’I Ching ci porta all’attenzione, lo abbiamo capito tutti. È sempre bello, però, ricamare sugli input proposti un argomento valido per discorrere e discorrere, riflettere e rimettere in gioco vecchie convinzioni, avere la possibilità di ribaltare ogni idea. In questo particolare caso, non mi metterò a fare il misterioso, descrivendo mano a mano la figura dell’artista aggiungendo particolari: è bene andare diritto a uno dei punti per cui adoro i pianisti.
Herbert Jeffrey Hancock nasce a Chicago nel 1940 e inizia a suonare il pianoforte a sette anni: sono passati sessantanove anni, e non ha ancora smesso di farlo. Questo musicista dall’animo gioviale, amico fraterno di Wayne Shorter da ormai sessant’anni, è un emblema vivente, nella musica moderna, del rinnovamento: la necessità di elementi e suoni freschi, in parallelo con lo sviluppo socio-culturale, ma anche tecnologico, della società.
La scuola su cui Hancock pone le basi del proprio bagaglio musicale è la più efficace esistente, cioè l’ascolto e la trascrizione della musica direttamente dal disco originale, consumato fino al possibile per sviscerarne ogni singolo carattere distintivo. Il giovane Herbert, a soli diciassette anni, trascrive parti orchestrali direttamente da dischi di Big Band quali quelli di Count Basie (1904-1984) e Duke Ellington (1899-1974), per organizzare un concerto epocale nel suo liceo, mai accaduto prima nell’istituto, chiamando musicisti da dentro e fuori la scuola, insegnando loro la pronuncia (parliamo della fine degli anni Cinquanta e allora anche negli Stati Uniti era difficile trovare giovani che conoscessero il fraseggio jazzistico), arrangiando tutti i brani. Il suo percorso è fulminante, costellato da centinaia di occasioni e situazioni in cui le sue capacità di strumentista vengono quasi messe in secondo piano in confronto ad altre qualità, quali la composizione, la bramosia di rinnovamento, l’umiltà, la necessità di andare avanti e mai tornare indietro: l’eterna scoperta. Leggendo Possibilities, la sua autobiografia, sembra di avere a che fare con un ragazzino interessato, ghiotto, desideroso di cogliere il bello, l’utile, la novità che circonda il momento, anche quando il racconto descrive un’esperienza in età avanzata. La curiosità rende artista un musicista: Herbie Hancock è sicuramente un inguaribile curioso.
Il compimento si riferisce a un momento, quell’attimo irripetibile che il “grande capo” della nostra amata rivista descrive giustamente: perfetto, coronato, “confetto”. Tutto ciò, immancabilmente, ha un grande nesso con l’arte, ma non sembra esserci bisogno di dirlo: che arte potrebbe mai essere, se non fosse riferita al contesto, al momento in cui l’opera viene data alla luce? Un’analisi superficiale ci porterebbe a dire che ci sono arti che ragionano in senso spaziale, come possono essere la scultura e l’architettura; altre, come la musica, in senso orizzontalmente temporale. Potremmo tuttavia dire che, in un certo senso, tutte abbiano un valore temporale portando all’attenzione i vari attimi in cui ogni singolo mattoncino è stato posizionato per erigere il prodotto finito: quando ha capito di voler produrre quello che ha prodotto? Quando ha imparato a svolgere quel mestiere in senso pratico? Ma soprattutto, mentre lo stava creando, quanti infiniti momenti di pura ispirazione lo hanno portato a muovere il pennello, calcare la penna, spostare le dita sui tasti, in una direzione piuttosto che un’altra?
La mia creatura è qua di fronte (per la musica è più complicato, potremmo immaginarci il prodotto fisico, il disco) e ho la certezza comprovata che questo materiale abbia avuto il riscontro che speravo. Ormai molta gente si ricorda di me per questo bel prodotto: sono davvero soddisfatto, e non solo io. È andata talmente bene che rischio di essere associato come persona a quello che sono stato in grado di generare: è passato del tempo, però, e la mia vita va avanti. Come posso fare per rendermi nuovo, creativo, interessante, interessato, geniale, per la seconda volta?
Nel 1963 Hancock viene chiamato da Miles Davis (1926-1991) per far parte del suo nuovo quintetto, che sarà composto da Tony Williams (1945-1997) alla batteria, Ron Carter (1937) al contrabbasso, e Wayne Shorter (1933) al sassofono. The Great Second Miles Davis Quintet. Questo gruppo prenderà per le orecchie la musica jazz in quanto ensemble di stilemi che iniziavano a stare stretti, portandoli a un radicale progresso specialmente in termini di connessione tra i musicisti stessi: il materiale maggiormente avveniristico che questo complesso porta avanti è quello del dialogo tra gli elementi della sezione ritmica, snaturandosi, evolvendo, implodendo ed esplodendo, rendendo ogni brano un campo di possibilità per un racconto fatto di colori, suoni, energia e stupore.
Hancock nel suo libro racconta un aneddoto di quel periodo: Davis, una volta finito il suo solo, era solito allontanarsi dal palco, farsi un giro per lasciare campo libero a Shorter e compagni. Dopo le sue solite due, tre sigarette, tornato nella sala, prima di salire sul palco si avvicina a un suo conoscente tra il pubblico sussurrandogli: «Aspetta, ma che brano stavamo suonando?».
Questo episodio la dice lunga su quanto fosse potente il lavoro di ridimensionamento degli schemi nell’ambito di un piccolo gruppo che, più che lavorare stilisticamente sugli accordi e la melodia sovrastante, stupisce e si diverte a costruire su altri canoni.
Dopo l’estate del 1968, anche per colpa di un malinteso legato al protrarsi della propria luna di miele, Hancock termina il suo ingaggio con il quintetto di Davis. Ebbene, dopo cinque anni in cui suonare significava aprire possibilità espressive, concludere il rapporto voleva dire dover trovare qualcos’altro, necessariamente diverso, per poter banalmente andare avanti.
Il grande merito di un personaggio come Hancock arriva proprio in questo periodo, come anche nel 1974: momenti in cui una grande esperienza con un super-progetto finisce di esistere, come è giusto che sia. È necessario reinventarsi, per poter sfamare una grande voglia di sperimentare.
L’epoca in cui tutto ciò è accaduto lo ha favorito senz’altro (e qui torniamo a: in che momento è accaduto questo e quello?), perché proprio in quel periodo hanno iniziato a prendere piede, in tutti i generi, gli strumenti elettrici, in particolare chitarre e basso, le tastiere e i sintetizzatori. Durante la sua lunga carriera, Hancock cita e racconta di centinaia di strumenti su cui lui e suoi amici ingegneri o intenditori hanno lavorato per scoprire le possibilità che questa nuovissima tecnologia stava e avrebbe lungamente portato. I due grandi progetti successivi al quintetto che hanno nutrito il suo cuore di musica si chiamano Herbie Hancock Sextet (rinominato poi Mwandishi) e Head Hunters.
Il primo, messo in piedi verso la fine degli anni Sessanta, è un sestetto, un gruppo coloratissimo che avrebbe acceso in Hancock delle luci che ancora oggi si porta dietro, navigando in acque di grande sperimentazione – a volte addirittura eccessiva, dice. I dischi che questo gruppo ha inciso sono una pagina spesso cruda e introspettiva di un periodo in cui il pianista viveva momenti di altalenante stabilità fisica e mentale: questo complesso mi insegna ancora una volta a dedicare attenzione alla vicinanza indomabile tra il vissuto del compositore e la composizione.
Il secondo gruppo, gli Head Hunters, sono forse il prodotto musicale per cui Hancock è tutt’ora più famoso, cioè la sua era del funk. Questo passaggio nasce da un desiderio di svoltare dopo le sperimentazioni profonde dei Mwandishi (che non ho ancora detto essere la traduzione di “compositore” in lingua Swahili), ma anche dalla voglia di avvicinarsi di più al pubblico e divertire. Il primo disco, sulle orme della solarità espressa nel precedente Fat Albert Rotunda, è Herbie Hancock and the Head Hunters (il titolo in inglese vuol dire tante cose, tra cui un’allusione sessuale), conosciuto col semplice nome di Head Hunters. Associando funk a sonorità africane e arrangiamenti divertiti di vecchi capolavori, vende un’infinità di copie, consegnandosi finalmente al grande pubblico.
Herbie Hancock ha vissuto numerose decadi all’interno del grande mondo della musica moderna, suonando in platee di diversa qualità, generi spesso molto lontani tra loro (una volta addirittura in una stessa sera jazz, funk e sperimentazioni psichedeliche in tre momenti susseguenti), ma non riesce a levarsi di dosso questa espressione curiosa, quasi infantile, come un bambino alla scoperta di sempre nuovi giocattoli, anche a sessant’anni. Racconta il pianista di un’esperienza accadutagli nell’anno 2011 (quindi a settantun anni di età) quando gli viene proposto di suonare un complesso brano di musica classica contemporanea, Er Huang, scritto dal compositore Qigang Chen (1951): roba da quattro pentagrammi, non so se mi spiego.
Colto dalla curiosità nell’affrontare un genere musicale che lo ha attraversato prepotentemente da ragazzo per poi essere allontanato, decide ovviamente di accettare e si mette a studiare, proprio come faceva a dieci, undici anni. Considerata l’allucinante difficoltà del brano, chiede aiuto a Joanne Pearce Martin, una pianista classica di altissimo profilo, per farsi dare una mano nei punti più complicati (ciò dà un’idea dello spessore di quest’uomo: dopo sessant’anni di pianoforte, abbassare di nuovo il capo e farsi dare consigli… ma il bello deve ancora arrivare)… alla prima lezione, Joanne gli fa notare una cosa: «Herbie, tu non fai attenzione alla mano sinistra. Ti concentri sulla mano destra, e la sinistra le va dietro».
A quanto pare, era vero. Da quel giorno, nelle sue infinite ore di studio in preparazione al grande concerto, Hancock studiò le scale, come un ragazzino, concentrandosi sulla mano sinistra: il concerto andò alla grande.
Che cosa dire d’altro, se non che non esiste modo più plateale per dimostrare un viscerale bisogno di reinventarsi?
Il mio desiderio nel voler parlare di questa figura nasce dalla voglia di ringraziarlo per quello che umanamente ha offerto al mondo della musica, che porta avanti anche grazie al suo avvicinamento al buddhismo. Studio, amore, scoperta, dedizione, reinvenzione, meditazione: non ho altro da aggiungere, se non che senza Herbie non esisterebbe nemmeno l’hip hop! Take it!
Discografia
1964 – Empyrean Isles
1965 – Maiden Voyage
1968 – Speak Like a Child
1969 – The Prisoner
1969 – Fat Albert Rotunda
1970 – Mwandishi
1973 – Head Hunters
1974 – Thrust
1975 – Man-Child
1976 – VSOP
1979 – The Piano
1983 – Future Shock
Bibliografia
Herbie Hancock con Lisa Dickey, Possibilities. L’autobiografia, tr. it. di Michele Piumini, minimum fax, 2015.